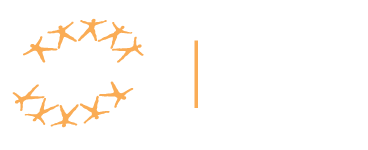Risultati dello studio “Immobili pubblici: Patrimonio da valorizzare”
Numerose sono state le iniziative avviate negli ultimi trent’anni per trasformare gli immobili pubblici da elemento passivo a un asset strategico. Nel tempo, questa visione si è concretizzata in una serie di interventi normativi: dalla dismissione diretta come misura straordinaria, alla cartolarizzazione finanziaria, fino all’adozione di strumenti più avanzati per la gestione attiva del patrimonio, basati su logiche di valorizzazione, partnership pubblico-privato e rigenerazione urbana. Da un punto di vista tecnico negli anni, il patrimonio pubblico a partire dagli anni 90 è stato oggetto di mappature, censimenti, classificazioni e trasferimenti giuridici tra Enti, con l’introduzione di nuovi attori come l’Agenzia del Demanio (Decreto legge 300/99), Invimit (Decreto ministeriale del 19.03.2012), oltre all’adozione di strumenti giuridici innovativi: fondi immobiliari, concessioni di valorizzazione, società veicolo (SPV), conferimenti patrimoniali a titolo gratuito e programmi unitari di valorizzazione territoriale (PUVaT).
Dopo aver effettuato la registrazione al nostro sito, lo studio in versione integrale è visualizzabile al seguento link https://eurispes.eu/ricerca-rapporto/immobili-pubblici-patrimonio-da-valorizzare-2025/
Nonostante i diversi tentativi delle differenti Legislazioni, i risultati sono stati eterogenei e spesso discontinui, a causa di ostacoli strutturali: incertezze normative, carenza di competenze tecniche, debolezza della governance locale, ma anche resistenze culturali e amministrative rispetto alla gestione manageriale del patrimonio. Se guardiamo alle traiettorie macroeconomiche delle principali grandezze della finanza pubblica italiana dagli anni Novanta a oggi, si evince che la strategia di valorizzazione del patrimonio immobiliare non ha prodotto effetti strutturali complessivamente limitati e discontinui sul riequilibrio dei saldi pubblici. Anzi, al contrario, i principali indicatori mostrano una tendenza persistente e, in alcuni casi, accentuata al deterioramento.
Nonostante le ripetute operazioni di dismissione negli anni (fondi immobiliari pubblici, cartolarizzazioni, valorizzazioni), l’impatto sul debito pubblico è stato pressoché trascurabile, sia in termini assoluti (proventi limitati rispetto allo stock di debito) sia in termini dinamici (assenza di effetti di stabilizzazione di lungo periodo). Il rapporto tra debito pubblico e Prodotto interno lordo (Pil) – che rappresenta il principale parametro di sostenibilità delle finanze pubbliche, oltre che un riferimento centrale nei vincoli del Patto di stabilità europeo – ha mostrato un andamento strutturalmente crescente, passando dal 104% nel 1992 (anno di approvazione della legge n.537/1993, una delle prime misure rilevanti di razionalizzazione della spesa pubblica, con implicazioni anche in materia patrimoniale), fino a superare il 140% nel 2020, in seguito alla crisi pandemica, e attestandosi ancora oggi su valori prossimi o superiori al 137% (dati MEF – DEF 2023).
Il saldo netto da finanziare in rapporto al Pil, ovvero il disavanzo complessivo del bilancio dello Stato, non ha beneficiato in modo significativo delle entrate straordinarie derivanti dalla valorizzazione patrimoniale. Le entrate da alienazioni, per quanto formalmente registrate nel bilancio dello Stato o degli Enti locali, sono state per lo più episodiche e condizionate da fattori di mercato. La valorizzazione patrimoniale dunque non ha inciso in modo permanente sui flussi strutturali del bilancio pubblico.
Infine il saldo primario, ovvero la differenza tra entrate e spese al netto degli interessi sul debito, considerato dagli economisti il vero indicatore di “sforzo fiscale” di uno Stato, ha storicamente registrato avanzi primari positivi per diversi anni (soprattutto tra il 1995 e il 2007), ma negli ultimi dieci anni tale capacità si è progressivamente indebolita. Le operazioni patrimoniali, in questo quadro, non hanno generato flussi primari aggiuntivi, né in forma di risparmi strutturali (ad esempio, razionalizzazione dei costi di locazione), né in forma di nuove entrate ricorrenti.
La lezione emersa dagli ultimi trent’anni è chiara: la valorizzazione del patrimonio pubblico può contribuire alla finanza pubblica, ma non può sostituirsi a una strategia fiscale coerente e strutturale. L’illusione che il patrimonio possa da solo riequilibrare i conti si è scontrata con la realtà di un sistema pubblico complesso, in cui la creazione di valore richiede tempo, competenze, investimenti e – soprattutto – una visione politica e amministrativa di lungo periodo.
Tuttavia, le riforme più recenti segnano una fase più matura del processo: la valorizzazione degli immobili pubblici non è più solo strumento di riequilibrio finanziario, ma anche leva per la trasformazione urbana, la sostenibilità ambientale e l’inclusione sociale. L’obiettivo del Legislatore dovrà essere quello di trasformare il patrimonio in un volàno per la crescita sostenibile, la coesione territoriale e la transizione ecologica. In quest’ottica, ogni operazione di valorizzazione non dovrà più essere vista solo come un’opportunità economica, ma come un intervento che può contribuire al benessere collettivo, alla rigenerazione delle città, al contenimento del consumo di suolo e al raggiungimento degli obiettivi ambientali nazionali ed europei.
A testimonianza dell’evoluzione di questo nuovo paradigma di valorizzazione dei beni immobili, il Ministero dell’Economia e Finanza (MEF) ha promosso, nel novembre 2024, l’insediamento della “Cabina di regia per la valorizzazione e la dismissione del patrimonio immobiliare pubblico”, prevista dall’art. 28-quinquies del Dl 75/2023, convertito con modificazioni dalla legge 112/2023. La composizione della Cabina prevede la partecipazione dei rappresentanti delle Amministrazioni Centrali maggiormente coinvolte nella gestione patrimoniale.
La lettura integrata tra dimensione numerica e dimensione spaziale conferma che il patrimonio immobiliare pubblico italiano è altamente eterogeneo, territorialmente disperso e fortemente sbilanciato sul segmento residenziale in termini di numerosità, ma su quello istituzionale in termini di superficie e valore d’uso. Ne deriva la necessità di adottare una strategia differenziata e multi-livello, che tenga conto della funzione prevalente degli immobili, della loro obsolescenza tecnica e funzionale, del contesto territoriale e delle potenzialità di valorizzazione. In tale prospettiva, una pianificazione patrimoniale consapevole può trasformare l’attuale patrimonio da passività in leva di sviluppo territoriale, sostenibilità e modernizzazione dell’Amministrazione pubblica.
È necessario strutturare un approccio fondato su logiche settoriali, che consideri in modo distinto almeno tre grandi aree funzionali del patrimonio.
Gli immobili strumentali all’erogazione di servizi pubblici essenziali costituiscono il nocciolo operativo e funzionale dell’infrastruttura pubblica nazionale, rappresentando quegli asset che, per la loro destinazione d’uso diretta, risultano imprescindibili per l’erogazione continua, regolare e universalistica di servizi fondamentali quali l’istruzione, l’amministrazione pubblica, la sanità territoriale, lo sport, la sicurezza, la giustizia e l’inclusione sociale.
La gestione degli immobili strumentali deve essere ispirata a criteri di economicità e funzionalità, nonché alla massimizzazione del rendimento d’uso, in un’ottica non commerciale ma di piena valorizzazione del capitale pubblico. In tale direzione, sono fondamentali: la razionalizzazione dei volumi occupati, tramite processi di accorpamento, rilocalizzazione o condivisione di spazi tra uffici o enti diversi (logiche “hub pubblici” e “poli amministrativi integrati”); l’adozione di modelli organizzativi flessibili, come lo smart working, il desk sharing e la digitalizzazione front-end/back-office, che modificano radicalmente la domanda di spazi; l’introduzione di indicatori di performance tecnico-gestionale, quali il costo annuo per mq, il tasso di utilizzo effettivo, il fabbisogno manutentivo previsionale, la resilienza energetica e la compatibilità ambientale.
L’obiettivo è ridurre i costi fissi, aumentare la qualità ambientale e migliorare l’accessibilità e la trasparenza dei servizi, anche attraverso la digitalizzazione delle postazioni di lavoro e degli sportelli al cittadino.
L’obsolescenza di una larga parte degli immobili strumentali richiede interventi strutturali su larga scala, che non si limitino alla manutenzione straordinaria. Tali interventi richiedono una programmazione integrata e multi-fonte, capace di combinare risorse nazionali, europee e comunali con strumenti di supporto tecnico-finanziario messi a disposizione da soggetti pubblici (Cassa Depositi e Prestiti -CDP-, Agenzia del Demanio, Invitalia, Consip). Il patrimonio strumentale, se valorizzato nel modo giusto, può davvero diventare un motore per la trasformazione digitale e amministrativa dello Stato, aiutando a creare un’Amministrazione pubblica più vicina, accessibile e sostenibile. Avere infrastrutture adeguate è fondamentale per innovare nei servizi, ridurre la burocrazia, semplificare i processi e promuovere la coesione territoriale.
In questo contesto, il patrimonio strumentale non è solo un semplice spazio fisico, ma un bene pubblico cruciale, la cui efficienza influisce direttamente sulla qualità della vita collettiva e sulla capacità dello Stato di raggiungere i suoi obiettivi costituzionali. Come sottolineato nel documento Piano Struttura di Bilancio di Medio Termine – Italia 2025-2029, il Governo italiano ha in programma di sviluppare nei prossimi anni diversi progetti focalizzati principalmente sulla riconversione a fini sociali di social housing, studentati e asili nido.
In particolare, per quanto riguarda il social housing il quadro normativo è frammentato e poco coordinato, composto una molteplicità di definizioni e strumenti regionali e locali, spesso non coordinati tra loro. L’associazione frequente con l’edilizia popolare (ex IACP/ERP) contribuisce a una percezione distorta, che ne oscura le caratteristiche distintive: canone calmierato, criteri di accesso legati a fasce intermedie di reddito, mix funzionale, servizi condivisi, coinvolgimento del privato nella progettazione e nella gestione.
Per quanto riguarda invece la domanda di alloggi universitari, la trasformazione di edifici dismessi in residenze per studenti rappresenta un’opportunità importante per soddisfare la crescente richiesta di spazi abitativi da parte degli studenti. Questo approccio non solo valorizza il patrimonio immobiliare esistente, ma promuove anche la rigenerazione urbana.
Le iniziative istituzionali e le semplificazioni normative sono state introdotte per incentivare questi interventi, contribuendo a ridurre il divario tra domanda e offerta nel settore dell’housing universitario in Italia. Attualmente, il nostro Paese offre circa 85.000 posti letto per studenti universitari, con un numero sempre crescente di strutture moderne gestite da operatori specializzati. Secondo il Rapporto “Lo student housing da mercato di nicchia a comparto maturo” di Scenari Immobiliari e Re.Uni, si prevede che entro il 2027 l’offerta supererà le 100.000 unità, con la maggior parte delle nuove aperture attese nel 2026.
Nonostante questi progressi, il tasso di copertura rimane al di sotto della media europea, evidenziando la necessità di ulteriori interventi per colmare il divario tra domanda e offerta. In Europa, la disponibilità di alloggi per studenti, noti come Purpose-Built Student Accommodation (PBSA), varia notevolmente da un paese all’altro. Secondo il Rapporto “European PBSA: Investing in the Future” di Jones Lang LaSalle, una delle principali società internazionali di servizi professionali nel settore immobiliare, la media europea del tasso di copertura degli alloggi per studenti si attesta intorno al 25%. Tuttavia, questo valore presenta notevoli differenze: nel Regno Unito, ad esempio, il tasso di copertura arriva al 33%, mentre in Italia si ferma al 4%.
Queste discrepanze evidenziano la necessità di ulteriori investimenti nel settore degli alloggi per studenti in paesi come l’Italia, dove la domanda supera di gran lunga l’offerta attuale. Inoltre, la crescita del numero di studenti internazionali in Europa accentua ulteriormente la pressione sulla disponibilità di alloggi adeguati.
In risposta a questa esigenza, il Ministero dell’Università e della Ricerca (MUR) ha promosso un bando, finanziato con risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), per la creazione di almeno 60.000 nuovi posti letto per studenti universitari entro il 30 giugno 2026. Il bando prevede un contributo di circa 20.000 euro per ciascun nuovo posto letto, destinato a coprire parte dei costi di gestione nei primi tre anni di esercizio delle strutture.
Inoltre, per facilitare la trasformazione di immobili dismessi in residenze universitarie, il decreto legge 2 marzo 2024, n. 19 ha facilitato il cambio di destinazione d’uso degli immobili esistenti in residenze universitarie mediante Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), anche in deroga alle prescrizioni degli strumenti urbanistici locali. Inoltre, gli interventi di ristrutturazione edilizia possono prevedere aumenti di volumetria fino al 35% di quella originaria, e gli alloggi per studenti finanziati dal PNRR non sono soggetti all’obbligo di reperire ulteriori aree standard né alla dotazione minima di parcheggi prevista dalla normativa vigente.
Infine, per quanto riguarda gli Asili nido, l’investimento nei servizi educativi per la prima infanzia è oggi una delle sfide più urgenti e strategiche per il futuro del nostro Paese. Assicurare un accesso ampio e di qualità agli asili nido non è solo una questione di equità educativa, ma rappresenta anche un potente strumento per l’inclusione sociale, la promozione dell’occupazione femminile e il riequilibrio territoriale. Tuttavia, la situazione in Italia presenta ancora gravi criticità.
La copertura nazionale dei servizi educativi per la prima infanzia è ben al di sotto degli obiettivi europei: secondo i dati del Ministero dell’Istruzione e del Merito, aggiornati nel contesto del monitoraggio del PNRR, la media nazionale di posti disponibili per i bambini da 0 a 2 anni è solo del 15,7%, rispetto al target minimo europeo del 33% stabilito nella “Strategia di Barcellona” e confermato nel Piano d’azione europeo per l’istruzione e la cura della prima infanzia.
Le disparità territoriali sono molto evidenti: nelle regioni del Centro-Nord si registrano valori più vicini al parametro europeo, con punte del 32% in Emilia-Romagna e Toscana, mentre nel Mezzogiorno il dato scende spesso sotto il 10%, come nel caso di Calabria, Sicilia e Campania. In alcune aree interne o periferiche, l’offerta è completamente assente o estremamente frammentata. A confermare questa situazione è anche l’Istat, nel Rapporto “Asili nido e altri servizi socio-educativi per la prima infanzia – anno educativo 2021/2022”, che mette in luce come oltre un terzo dei Comuni italiani non offra alcun servizio educativo per i bambini sotto i tre anni.
In questo contesto, la riqualificazione e la riconversione del patrimonio immobiliare pubblico inutilizzato in strutture educative per la prima infanzia può costituire una leva fondamentale di trasformazione. Da un lato, consente di recuperare immobili in disuso, evitando consumo di suolo e contenendo i costi di costruzione; dall’altro, offre l’opportunità di creare luoghi educativi moderni, sostenibili, accessibili e integrati nel tessuto urbano. Laddove ciò non sia possibile, risulta comunque imprescindibile l’ammodernamento degli edifici esistenti, molti dei quali risultano oggi inadeguati rispetto agli standard normativi ed educativi richiesti.
Gli immobili patrimoniali a reddito o potenzialmente tali sono beni che possono produrre redditività attraverso forme di concessione, locazione, valorizzazione, conferimento a fondi, o cessione, e che quindi devono essere oggetto di una gestione attiva, ispirata a logiche di efficienza economico-finanziaria e accountability pubblica.
Gli immobili a reddito pubblici sono parte di un portafoglio non strumentale che, se correttamente gestito, può contribuire al miglioramento della sostenibilità finanziaria delle Amministrazioni, ridurre il fabbisogno di spesa corrente e alimentare risorse da destinare a investimenti o alla riqualificazione degli immobili strumentali.
Tuttavia, nella prassi, questi immobili soffrono di numerose criticità: assenza di strategie di portafoglio integrate, spesso frammentate tra Enti diversi; mancata o irregolare contrattualizzazione dei rapporti d’uso, con conseguenti mancate entrate; canoni di concessione non aggiornati ai valori di mercato; sottoutilizzo o uso non coerente con le potenzialità locative; mancanza di anagrafi patrimoniali integrate (censimenti, valori, regolarità documentale e amministrativa).
In questo contesto, il passaggio da una gestione conservativa a una gestione attiva implica un cambio di paradigma che richiede l’introduzione di strumenti tecnici e gestionali propri del real estate management pubblico, con l’adozione di approcci sistemici alla valutazione, alla valorizzazione e al monitoraggio delle performance patrimoniali.
Tra gli strumenti attivabili, si segnalano: la revisione dei rapporti locativi e concessori, mediante aggiornamento dei canoni, recupero delle morosità e regolarizzazione contrattuale; l’alienazione selettiva di beni non strategici, previa valorizzazione urbanistica e tecnica, anche in ottica di housing, innovazione o rigenerazione urbana; il conferimento a fondi immobiliari pubblici o pubblico-privati, capaci di attivare risorse di mercato preservando il controllo pubblico (ad esempio, fondi di CDP Real Asset, Invimit Società di Gestione del Risparmio -SGR-); l’aggregazione in portafogli patrimoniali a gestione unitaria, con logiche di ottimizzazione fiscale, assicurativa e manutentiva; la promozione di partenariati con il Terzo settore o con imprese sociali, per la gestione di spazi ad alto impatto sociale ma non profittevoli per il mercato (laboratori artigianali, centri culturali, coworking civico, sportelli sociali).
L’approccio valorizzativo deve, inoltre, integrarsi con gli strumenti di programmazione urbanistica e di rigenerazione, attraverso la coerenza con i piani regolatori comunali, i piani urbani integrati e le strategie territoriali finanziate da fondi europei o PNRR.
Il passaggio a una gestione economica attiva del patrimonio a reddito richiede un rafforzamento significativo della capacità amministrativa. In particolare, occorre: istituire unità patrimoniali specializzate all’interno degli Enti locali, con competenze trasversali in campo tecnico, giuridico, urbanistico e finanziario; sviluppare cruscotti direzionali di gestione patrimoniale, basati su indicatori di performance (tasso di redditività, rendita netta, incidenza dei costi di gestione, grado di valorizzazione, rischio di deperimento); garantire trasparenza e tracciabilità delle scelte, anche tramite piattaforme pubbliche di consultazione e reporting (open data patrimoniali, bilancio patrimoniale aggiornato, dashboard digitali); favorire la cooperazione interistituzionale per la gestione di immobili in uso promiscuo, multiproprietà pubblica o contesti metropolitani complessi.
In definitiva, gli immobili patrimoniali pubblici devono essere trattati come asset dinamici, da cui estrarre valore economico, sociale e territoriale attraverso una governance moderna, fondata su conoscenza, professionalità e innovazione.
Gli immobili dismessi, sottoutilizzati o in stato di degrado rappresentano, all’interno del patrimonio immobiliare pubblico, una quota significativa di beni che, pur essendo formalmente in carico alle Amministrazioni, non sono più funzionalmente attivi, non rispondono a una destinazione coerente, oppure versano in condizioni strutturali e gestionali tali da precluderne l’uso regolare. Si tratta di immobili inutilizzati, in abbandono, vetusti, in stato di degrado avanzato, privi di destinazione urbanistica attuale, o comunque non rispondenti a criteri minimi di sicurezza, accessibilità, funzionalità o sostenibilità economica. In molti casi, questi beni sono localizzati in aree interne, piccoli Comuni, periferie urbane o territori a declino demografico e socioeconomico.
In questo contesto, gli immobili abbandonati generano effetti negativi multipli. Nonostante le criticità, questa parte di patrimonio può costituire una riserva strategica di valore latente, attivabile a condizione di individuare usi alternativi compatibili, sostenibili e contestualizzati. In presenza di condizioni favorevoli, gli immobili dismessi possono essere oggetto di processi di rigenerazione urbana, riuso temporaneo, trasformazione funzionale, riconversione sociale o valorizzazione a fini collettivi.
I percorsi attivabili includono: la messa a reddito post-riqualificazione, mediante concessione, locazione o vendita; l’attivazione di partenariati pubblico-privati o con soggetti del Terzo settore, tramite bandi per la concessione di immobili a uso sociale, culturale, ambientale o abitativo (ad esempio, modelli di co-housing, spazi civici, luoghi della cultura); il ricorso a fondi immobiliari o strumenti ad hoc, in particolare per immobili localizzati in aree con potenziale turistico, agricolo o produttivo; la cessione a titolo oneroso o gratuito, a Enti pubblici o privati, sulla base del principio dell’interesse generale o dell’efficienza economica, con priorità per progetti coerenti con le politiche pubbliche locali; la demolizione selettiva con recupero del suolo, in casi di degrado irreversibile e mancanza di fattibilità tecnica o economica della riqualificazione.
Negli ultimi anni, non sono mancati esempi virtuosi di riuso di edifici dismessi, trasformati in asili nido, studentati, alloggi sociali, spazi culturali, sedi amministrative o strutture per l’innovazione.
Tuttavia, tutte queste iniziative sembrano ancora una costellazione disomogenea di interventi locali, senza una visione strategica unitaria e duratura. Fino all’istituzione della Cabina di regia del MEF, a livello centrale, è mancato un vero e proprio piano organico per la riconversione del patrimonio immobiliare pubblico, capace di integrare aspetti urbanistici, economici, sociali e ambientali. Questo avrebbe garantito l’efficacia delle operazioni, la sostenibilità nel tempo degli usi previsti e la coerenza con le priorità di welfare territoriale.
In mancanza di una governance chiara, molti immobili pubblici sono rimasti abbandonati (nel 2018, circa 22.000 edifici erano inutilizzati) o sottoutilizzati, nonostante il loro potenziale per soddisfare esigenze concrete e diffuse. Per questo motivo, è sempre più urgente definire un modello di intervento che combini strumenti normativi chiari, banche dati affidabili, un ruolo attivo delle Amministrazioni locali e il coinvolgimento del settore privato, tutto in un’ottica di interesse pubblico. Per questo, è necessario adottare una strategia fondata su una valutazione multidimensionale, che consideri: la localizzazione e il contesto urbano (densità abitativa, domanda sociale, mercato locale, accessibilità); la consistenza tecnica ed economica dell’immobile (superficie, stato di conservazione, grado di vincolo, potenziale trasformativo); la disponibilità di risorse finanziarie e partner operativi, pubblici o privati; la coerenza con le strategie di sviluppo territoriale, i piani urbanistici comunali, i programmi di finanziamento europei (PNRR, Fondo Sociale Europeo -FSE-, ecc.) o altri strumenti di pianificazione integrata.
Infine, la valorizzazione degli immobili dismessi richiede capacità tecniche elevate e non sempre disponibili presso gli Enti locali proprietari, soprattutto nei piccoli Comuni. Per questo motivo è fondamentale prevedere: il supporto operativo di soggetti tecnici nazionali, come Agenzia del Demanio, Cassa Depositi e Prestiti (CDP), Invitalia SGR; l’accesso a piattaforme digitali per la catalogazione, la promozione e la messa a bando degli immobili; la predisposizione di piani triennali di valorizzazione, in sinergia con gli strumenti di bilancio e con le strategie di sviluppo locale; la partecipazione a programmi di finanziamento integrato, capaci di sostenere le spese di progettazione, riqualificazione e gestione innovativa degli spazi.