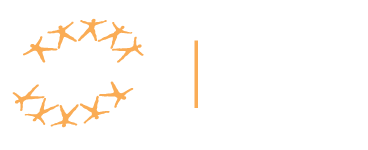Disponibili online gli atti del webinar su capitale umano, innovazione e tradizione. 10° Incontro promosso dal Laboratorio dell’Eurispes

A seguire sono disponibili gli atti del 10° Incontro promosso da Laboratorio sul capitale umano dell’Eurispes. Al centro del dibattito “Innovazione e Tradizione: costruire il futuro del lavoro tra cultura e impresa”.
L’incontro, si è svolto online il 10 aprile 2024. Hanno partecipano alla discussione: Antonio Calabrò, Presidente Museimpresa, Francesco Cacopardi, Direttore Centro Studi Istituto Luigi Gatti di APA Confartigianato Imprese Milano, Monza e Brianza, Guido Saracco, già Rettore del Politecnico di Torino, Benedetta Cosmi, Coordinatrice Laboratorio dell’Eurispes sul Capitale umano.
Benedetta Cosmi: Il mondo del lavoro, che a volte ha dei pregiudizi e degli stereotipi, ha anche dell’Innovazione da innescarsi all’interno di una tradizione, ed è questo un po’ il filo conduttore di oggi, anche grazie a miei ospiti, che ringrazio e saluto: Antonio Calabrò è il primo ospite a cui poi cederò la parola; abbiamo Guido Saracco, che è fresco di questa transizione da Rettore del Politecnico di Torino, quindi ci racconterà anche sulla viva pelle come si vivono i passaggi da un ruolo all’altro, una condizione che ormai riguarda proprio il mondo del lavoro in sé. Arriveremo poi, con un gioco di parole che è stato usato proprio da Confartigianato, a esaminare anche l’ “intelligenza artigianale”, che al di là dello slogan è qualcosa di veramente intrigante. Per passare la parola a te, Antonio ringraziandoti per i tuoi molti ruoli con cui guardi al mondo dell’Industria e quindi al mondo del lavoro e alla società, anche nella nell’aspetto della cultura, mi piacerebbe giocare su uno dei tuoi libri che parla proprio di orgoglio industriale. Passiamo quindi dall’orgoglio industriale e attraversiamo l’intelligenza Artigiana, quindi sicuramente abbiamo dentro tutte le sfumature; in mezzo c’è l’università che fa un po’ da collante nel mondo della formazione e nelle Skills, nelle competenze, nella capacità di rimanere legati a una, che è quella del Paese, ma di portarla a una società aperta, innovativa, capace di competere in modo sano con il meglio delle possibilità e opportunità che i giovani e meno giovani devono trovare anche nel nostro Paese. Quindi, a te la parola, grazie.
Antonio Calabrò: Grazie Benedetta, e grazie a tutti quelli che ci ascoltano. Grazie anche per avere ricordato “Orgoglio industriale”. È un libro Mondadori di 15 anni fa ed era stato scritto con un’idea di reazione a una opinione diffusa anti-impresa, che era abbastanza prevalente in molti circoli di questo Paese, come se noi non fossimo il grande Paese industriale che siamo. Non un Paese di grandi industrie, ma un Paese di piccole e medie imprese, filiere e di grandi industrie che fanno da capofila. Un Paese in movimento, un Paese che ha nella manifattura uno dei suoi cardini fondamentali, identitari. “Orgoglio industriale” nasce da lì, è un racconto di imprese che già all’epoca reggevano la competizione internazionale in quel momento complicatissimo, meno di adesso ma già complicato, che era l’indomani della grande crisi finanziaria, la crisi del debito, la crisi delle bolle speculative, la grande crisi di Wall Street del 2008 che poi aveva contagiato i mercati. Io credo che l’orgoglio industriale sia un altro punto su cui insistere ancora oggi in modo molto trasversale rispetto al mondo della produzione. Dunque, le imprese: imprese industriali, imprese artigiane, da questo punto di vista con tutte le differenze; non credo che ci siano, però, delle radicali diversità né delle contrapposizioni. Noi siamo un Paese produttivo, e il nostro essere produttivi è un punto di forza non soltanto rispetto all’economia, ma molto più rispetto al tessuto civile e sociale di questo Paese, per usare parole grosse, rispetto alla democrazia di questo Paese, perché le fabbriche, i laboratori, le officine, sono luoghi in cui lo stare insieme ha connotazioni che vanno al di là. Il tema di questa nostra conversazione si potrebbe anche dire in un altro modo e cioè: quali sono le ragioni che tengono in piedi la competitività del Paese? Come fa questo Paese a continuare a crescere, come deve fare per continuare a crescere? Il primo giudizio che potremmo tentare di dare è appunto il quadro competitivo internazionale. Noi oggi siamo in una condizione di particolari e drammatiche difficoltà, maggiori che non nel recente passato. Abbiamo affrontato la crisi del debito del 2008 e le nostre imprese sono state bravissime a ripartire a crescere: hanno investito, hanno innovato, hanno anche utilizzato bene i vantaggi fiscali di quel provvedimento sacrosanto che era Industria 4.0, che poi è stato sospeso, che è stato finanziato meno del dovuto, che non è stato seguito con convinzione – per fortuna il Governo Draghi lo ha rimesso in movimento e adesso possiamo parlare convintamente di Industria 5.0. Capacità manifatturiera, tradizione, innovazione. Ma oggi il punto di incertezza vero, dopo il Covid, è legato agli assetti internazionali, al quadro geopolitico di grande turbolenza e di grandi squilibri. Possiamo essere bravissimi a innovare, trasformare le cose, a occupare le nicchie a maggior valore aggiunto sui mercati globali, ma le tensioni di guerra bloccano, per esempio, uno di quei canali fondamentali attraverso cui passano materie prime, semilavorati e merci italiane che è il Mar Rosso. Ecco, dobbiamo imparare a vivere in una stagione di incertezza e di turbolenza. Così gravi non le abbiamo mai conosciute le turbolenze, e abbiamo davanti a noi un orizzonte molto complicato perché è determinato per esempio dall’andamento delle prossime elezioni europee. Che Europa vorranno i cittadini europei che voteranno, un’Europa salvadanaio, un’Europa delle Nazioni che si accordano su alcune questioni essenziali ma minime, dei rapporti economici, o un’Europa più integrata, con un mercato unico, con quel mercato unico su cui adesso stanno studiando correttamente Enrico Letta e Mario Draghi su incarico della Commissione Europea. E questa Europa sarà capace di darsi una politica della sicurezza, che vuol dire energia, difese, materie prime? Una politica industriale, una politica fiscale, una politica sociale per affrontare la competizione che viene dagli Stati Uniti, dall’India, dalla Cina? Saremo in grado di affrontare questo tema? E le elezioni americane che contesto ci restituiranno dal punto di vista del sostegno pubblico degli Stati Uniti all’economia? Ci muoviamo, insomma, dentro incertezza e turbolenza. Dentro questo quadro noi, impresa italiana, rivendicando intanto una politica industriale europea, su quali leve possiamo fare affidamento? Qui c’è l’intelligenza al vostro titolo: innovazione e tradizione. La prima citazione facile che viene in mente, iper-nota, è quella frase essenziale di Carlo Maria Cipolla che diceva che gli italiani sono abituati fin dal Medioevo a produrre all’ombra dei campanili cose belle che piacciono al mondo. Cipolla era un genio: la capacità di sintesi sulla nostra identità imprenditoriale e sulla nostra capacità di progettare il futuro, una capacità di sintesi del genere è davvero rara. Io credo che Cipolla in quella frase lunga come un tweet abbia colto alcuni elementi che oggi sono leve di forza della nostra impresa: la nostra storia, sapendo che in un mondo competitivo come quello che stiamo vivendo puoi copiare di tutto, puoi aggirare i brevetti, puoi andare sulla scia delle innovazioni altrui – Guido Saracco è molto più bravo e competente di me da questo punto di vista. Ma una cosa non la puoi copiare: il dato identitario, la storia, e la nostra storia è un nostro clamoroso punto di forza, se noi consideriamo la storia non come nostalgia del passato glorioso, e se consideriamo identità le nostre imprese, la nostra capacità di saper fare e fare bene come un’identità aperta, molteplice, inclusiva, anche contraddittoria. Un’identità in cui si vanno sommando pezzi di civiltà che nel corso del tempo sono arrivate dal Mediterraneo e all’Europa: il Made in Italy è la sintesi di tutto questo e forse sul Made in Italy vale la pena spendere una parola di chiarezza. Nell’accezione corrente il Made in Italy, se lo chiedessimo al grande pubblico, identificheremo tre settori: arredamento, abbigliamento, agroalimentare. Gli spaghetti, la moda, i divani – ovvero i mobili, il design. Però attenzione, perché se dall’opinione corrente io mi sposto ai dati sull’export, vedo che il settore in cui abbiamo il maggior valore aggiunto rispetto a quei 670 miliardi di export che fanno di noi uno dei paesi esportatori più potenti e più dinamici del mondo; se guardo quei dati, il settore che più incide sull’export è la metalmeccanica meccatronica: noi siamo un fantastico Paese meccatronico. Le imprese artigiane conoscono la trasformazione digitale, poche rispetto a quante sarebbe necessario, ma più di quanto non si percepisca generalmente. Delle 150.000 imprese in Confindustria, una quota non è ancora dentro la twin transition ambientale e digitale ma stiamo camminando lungo questa strada, sapendo che proprio le filiere produttive, che è una delle connotazioni forti del nostro panorama industriale, tengono insieme piccole e medie imprese e consentono alle piccole di stare dentro le dinamiche dell’Innovazione della trasformazione. Da soli non ce la facciamo; stando insieme – le filiere sono un modo per stare insieme, i distretti e meta-distretti e le reti sono modi per stare insieme – riusciamo ad affrontare questo contesto competitivo. In merito al produrre, occhio sulla capacità di produzione, e sulla capacità di produzione di quei settori che hanno al loro interno l’innovazione non soltanto del prodotto, ma moltissimo del produrre, del modo di fare le cose. Se penso alla sostenibilità e leggo i rapporti di Simbola, mi accorgo che le imprese italiane, quelle che hanno rapporto molto forte con i territori di provenienza, hanno una naturale tendenza alla sostenibilità, perché proprio il rapporto con la comunità di riferimento fa sì che sia necessario a quelle imprese avere un consenso sociale diffuso, un capitale sociale positivo per potere investire e crescere, e sono – per dirla in modo evangelico – lievito di comunità attive. Questa è una caratteristica che ha molto a che fare con un’altra dimensione, e cioè una specifica attitudine delle nostre imprese in settori che sono la meccanica, la meccatronica, la farmaceutica d’avanguardia, la chimica, la gomma, la cantieristica navale, l’aerospazio, una spiccata attitudine a seguire criteri di cultura Politecnica. So che è un’espressione che piace molto a Guido Saracco, così come piace ai miei amici del Politecnico di Milano. I due politecnici Milano e Torino sono uno dei punti di sicurezza di questo Paese; cultura politecnica, che vuol dire? Penso a Vittorini, ma penso anche alle radici in Carlo Cattaneo, penso all’applicazione di adesso, penso alla civiltà delle macchine. Cultura Politecnica che è una sintesi estremamente originale, molto italiana, di saperi umanistici e cultura scientifica; senso del bello e capacità di fare; i disegni meccanici di Leonardo e la bellezza di quei disegni meccanici. Tanto belli sono, che quando con Confindustria abbiamo aperto la sede di rappresentanza a Washington, abbiamo organizzato una mostra delle Tavole del codice Atlantico alla Public Library Martin Luther King di Washington, mostra di straordinario successo perché abbiamo portato al pubblico americano la testimonianza, coi disegni tecnici di Leonardo, del saper fare e del saper rappresentare. Ecco, questa cultura politecnica è un nostro punto di forza e ha a che fare con quello che siamo come Paese all’ombra dei campanili – dice giustamente Cipolla pensando alla nostra impresa diffusa sui territori – e con una capacità di cogliere le trasformazioni nel corso del tempo con una flessibilità, con un senso della misura, con un senso della qualità che altrove, in altri paesi produttivamente molto forti, non ci sono. Per guardare alla dimensione grande, noi facciamo su misura le Acciaierie, facciamo su misura gli impianti industriali, facciamo su misura le macchine per fare macchine, facciamo su misura la metalmeccanica d’avanguardia, facciamo su misura l’avionica più innovativa, facciamo su misura i prodotti farmaceutici più sofisticati. Questa idea della misura, che coincide con la qualità, che coincide con la bellezza, è una nostra caratteristica, un pezzo di quella cultura politecnica su cui vale la pena continuare a insistere. Il rapporto coi territori, da questo punto di vista, è fondamentale perché i territori sono sapienza e conoscenza, che si trasforma nel corso del tempo. Ecco, l’errore probabilmente è pensare al Made in Italy come il tipico e l’Amarcord: un errore gravissimo che non va commesso perché il Made in Italy è molto più sofisticato, molto più tecnologico, molto più capace di adattare i processi dell’Intelligenza Artificiale anche alle piccole botteghe artigiane lungo attività che si fanno insieme. Questo insieme, probabilmente, è la chiave di volta su cui il Sistema-Italia può avere un ruolo particolare all’interno dell’Europa. L’ultima considerazione ha a che fare con le persone. Ora, io lo so che spesso è un modo di dire: “noi imprese siamo le nostre persone”. Poi guardo questo e trovo bassi salari di ingresso per i giovani, trovo una presenza delle donne nel mondo del lavoro molto al di sotto delle stesse capacità di offerta e di domanda da parte del mercato, molto al di sotto di quanto le nostre università non producano, molto al di sotto di una originale tendenza delle nostre scuole politecniche di insegnare nei Politecnici non soltanto le materie scientifiche, le STEM (Science Technology Mathematics Engineering) ma anche le STEAM. L’idea che gli ingegneri studino filosofia è un’idea straordinaria; non si tratta soltanto di saper fare, ma di sapere perché stai facendo una cosa, e quali sono le ricadute. Ecco, noi abbiamo questo capitale umano che è capitale sociale, e val la pena scommettere profondamente e con convinzione sui nostri giovani. Da questo punto di vista, ed è l’ultima considerazione che faccio, sprecare l’occasione del PNRR – e spero che non si sprechi – sarebbe una responsabilità enorme che avremmo nei confronti delle nostre ragazze e dei nostri ragazzi. Mi fermerei qui.
Benedetta Cosmi: Grazie. Dunque, abbiamo visto la trasversalità dei saperi, che ha una tradizione perché è sempre stato così; visto che in Italia piace il “si è sempre fatto così” allora “si è sempre fatto così in altri tempi”, appunto, da prima di Leonardo in poi, e quindi cercare di abbattere i compartimenti stagni è uno degli obiettivi principali che ci siamo posti fin da subito con il Laboratorio; quindi, cercare di superare tutti quei limiti. Mi ricordo quando abbiamo avuto la Ministra Messa, a proposito di rettori e rettrici, che era alle prese con il superamento di quei vincoli che, per esempio, portavano ad avere una sola laurea, non potevi studiare contemporaneamente più materie, e quindi nel caso italiano più Facoltà, e questo ovviamente crea un vincolo, un limite, un una barriera al sapere che è assolutamente anomala, e quindi in parte è stata, diciamo, superata. Le curiosità interdisciplinari sono fondamentali per la ricerca e anche per l’innovazione di prodotto, innovazione di processo a cui facevi riferimento. Mi facevi pensare, con la citazione all’Europa, alla questione delle Infrastrutture europee, che invece avevamo affrontato con l’altro rettore – in quel caso presidente della Crui cioè Ferruccio Resta – cioè l’idea che le infrastrutture europee possono superare in quel caso altri limiti, quelli delle barriere tipiche di un paese rispetto a un bisogno che invece è maggiore, non può essere circoscritto da confini geografici, perché in alcuni casi per competere bisogna abbatterle quelle barriere quasi immaginarie. Quindi, sulla questione del PNRR il fatto di non aver infrastrutture europee è un limite, perché aver ridistribuito i soldi agli stessi paesi che poi in fondo sono quelli che alimentano, diciamo così, il credito o il debito comune, è un po’ ridicolo. Cioè tu vai a ridare soldi a quei paesi che non erano stati particolarmente in grado di colmare delle lacune spesso territoriali, quindi è ovvio che ci sarebbe servita una immaginazione europea su come invece fornire un continente, in quel caso un’Unione, di qualcosa in più, un quid in più, spesso sui temi della ricerca. L’abbiamo visto anche nel periodo del Covid, quando non veniva dall’Europa la risposta a certi prodotti, ma lo vediamo nella tecnologia dove coniamo più norme, seppur servono anche quelle, però coniamo più norme, cioè l’Europa è più normativa. Da questo punto di vista un impatto maggiore c’è in America, che è in grado, anche come risposta pubblica, di incentivare, quindi non ci sono solo i capitali privati, che già sono enormemente maggiori per numero anche, diciamo così, di popolazione. Poi c’è anche la capacità del pubblico di puntare su degli asset strategici, e allora arriviamo a te, Guido, sia nell’esperienza nel Politecnico sia tua individuale, e proseguiamo in questo immaginare il lavoro anche declinato, se vogliamo, alle città che fanno da innovazione, da motori pulsanti.
Guido Saracco: Sì, grazie. Mi ricollego a stimoli che sono arrivati da Antonio, poco fa, e che riguardano, come hai detto bene, anche la mia persona. Io ho pubblicato, nel giugno del 2023, un libro con un filosofo che è Maurizio Ferrari, uno dei pochi filosofi che hanno, come dire, un approccio positivista, cioè vedono le tecnologie come la sublimazione della creatività umana, cosa che di fatto sono. Quando le tecnologie vengono a svilupparsi ad affermarsi nella società solamente secondo logiche di profitto, chiaramente il rischio, in alcuni casi, è che si vada incontro a un aumento di disuguaglianza e a problematiche tipo sociale che poi vanno corrette. Ma, in generale, senza una persona che le concepisce ed è istruita per farlo, le tecnologie non esisterebbero, quindi sono per forza legate all’umano, anche l’Intelligenza artificiale. Il problema che ci siamo posti al Politecnico (e anche al Politecnico di Milano stanno facendo gli stessi passi da qualche tempo) è che se io continuavo a formare i miei ingegneri come abbiamo fatto per 160 anni, da quando siamo nati nel 1859, avrei fatto un cattivo servizio alla società e a quello che serve proprio alle imprese oggi. Perché abbiamo, credo, sbagliato a un certo punto – ma d’altra parte si navigava già a vista dopo il boom economico che ha visto il nostro Paese esplodere e diventare la quinta potenza mondiale economicamente parlando. Alla crescita della complessità abbiamo dato una risposta di una crescita di competenze, di specializzazioni, abbiamo nelle università partorito una serie di lauree che, oserei dire, formavano dei professionisti molto verticali, ma che non erano neanche capaci di comunicare tra di loro più di tanto. Cioè, non coltivavano la filosofia che si declina soprattutto in università come le nostre, tecnologiche, in etica delle tecnologie, non coltivavano una visione corretta del mondo, che è un sistema complesso in cui le tecnologie entravano. Cioè, non erano in grado di capire bene i problemi sociali, a cui ponevano soluzione con un prodotto efficace, un servizio efficace, ma neanche le implicazioni che potevano una volta introdotte nella società quelle tecnologie partorire, in un sistema che oggi incrocia addirittura 17 obiettivi di sviluppo sostenibile – a volte una cosa che va bene per una direzione, su un’altra produce dei cattivi effetti. Per fare questo con un cambiamento radicale della nostra offerta formativa, con l’introduzione delle Scienze della società, Filosofia, Sociologia, Economia, Diritto per fare alcuni esempi, anche Scienze Politiche perché quella benedetta tripla elica che finalmente, dopo tanti anni, riusciamo adesso a implementare, con le università che escono dal loro guscio e le imprese lo stesso (perché tanto devono stare sul mercato) la politica, un po’ più a fatica – e in politica ci sono molti follower e pochi leader in questo momento– allora, ci si sta venendo incontro. E per forza dobbiamo fare qualcosa di diverso rispetto a prima, perché una volta, quando la Fiat in questa città portava avanti l’economia (ha fatto esplodere Torino fino a farla diventare una metropoli da 1 milione e 200.000 abitanti nel ’74, adesso siamo 850.000), aveva lei un ruolo dominante nelle dinamiche economiche; la politica modulava la società per riequilibrare, e a noi veniva solo chiesto: “fate degli ingegneri”, come diciamo dalle nostre parti, “tagliati col falcetto”. L’ingegnere che usciva da noi era un nerd al più, totalmente inadatto a entrare nel mondo del lavoro subito. Aveva una potenzialità enorme ma doveva stare due anni non nelle piccole e medie imprese (lui non si fidava di loro e loro non si fidavano di questo ingegnere capoccione per risolvere i problemi day by day). Nella gran parte dei casi, questi ingegneri andavano nelle grandi imprese, che erano in grado di portarli in giro per il mondo per un paio di anni, dopo i quali avevano finalmente capito come funzionava il mondo, si erano arricchiti di quella dimensione sociale, economica, anche filosofico-manageriale di come funzionano le imprese. Oggi quindi abbiamo fatto questa grande trasformazione. Tu parlavi di interdisciplinarità; l’interdisciplinarità è diventata una cifra estesa in tutte le lauree di ingegneria, già lo era nelle architetture, ma per le architetture, costruendo intorno all’uomo e alle comunità era più facile, avevano già le scienze sociali dentro; noi le abbiamo introdotte con corsi, abbiamo introdotto moduli di grandi sfide, cioè, al secondo anno dopo un primo anno di scienze dure, si fan respirare i ragazzi; 3500 ingegneri e architetti che si mettono a lavorare in gruppo, non più di sei persone per gruppo, ispirati da un tecnologo analista per affrontare una grande sfida globale: riscaldamento globale, l’acqua e le materie prime, la riduzione di disuguaglianze sociali, la sanità del futuro, una popolazione invecchia; sono sei proposte ogni anno, arrivano esperti delle due anime del nostro patrimonio culturale, quella più scientifica tecnologica quella più umanistica, e cominciano a pensare in gruppo tenendo accesa la creatività, tenendo acceso il senso critico, cominciando imparare anche come si comunica. Poi alle magistrali si arriva a fare le Challenge, arriva un’impresa, ti lancia una sfida di innovazione, lavori in gruppo con quasi professionisti formati; di nuovo, lavori come oggi si lavora nelle imprese. Non ci si richiude più come un tempo nel comparto ingegneria meccanica della Fiat, tutti a fare disegni sul tecnigrafo, nel comparto economia; oramai si lavora in open space. In questo modo teniamo viva la creatività, che è essenziale, maturiamo senso critico e le soft skills, e facciamo ingegneri che sono più “plug and play” e che quindi sono anche in grado, sommando in sé un po’ tutte queste discipline, di entrare in una piccola media impresa e dare un colpo d’aria lì. Spesso, invece di formare una startup, si può fare una cosa su una startup già formata che ha bisogno di innovazione. Questa è la nostra grande speranza e quello che abbiamo fatto in questi anni, e sono felice di poter dire che il nuovo rettore è totalmente in continuità con questo – è sempre molto importante questo – e molte delle cose che abbiamo realizzato sono in sintonia, ma soprattutto, quelle che abbiamo abbozzato verranno realizzate qua a Torino, che diventa un laboratorio. Tu ricorderai la canzone di Sinatra, “If you can make it there you make it anywhere”: Torino è veramente in difficoltà, ma si sta tirando su e sta cercando di darsi da fare sul piano della cultura, del turismo, ma soprattutto di quella grande vocazione manifatturiera che ha bisogno di una collaborazione con Università di centri di ricerca e ha tanta potenzialità di ridefinirsi in chiavi diverse rispetto a quelle in cui dominava la Fiat. Grazie.
Benedetta Cosmi: io lì ho incontrato molti business angels, quindi è una vocazione che mi sembra interessante, che appunto scopre le start-up nei 3 anni dopo, quando sono sopravvissute; è vero che c’è una moria grande però, appunto, ci sono quelle che poi hanno bisogno di diventare più grandi ancora, e quindi lo fanno anche grazie a quel tipo di intuizioni e anche di capitale umano che è messo a disposizione dalle competenze manageriali di imprenditori, eccetera. Adesso arriviamo a una parte interessantissima, con te, Francesco Cacopardi, direttore Centro Studi Istituto Luigi Gatti di Apa Confartigianato imprese Milano Monza e Brianza, che poi non poteva essere settimana migliore perché siamo tutti in fibrillazione in attesa del Salone del mobile, quindi poco fa si citava, a proposito dell’esportazione, anche il Made in Italy legato appunto al mobile. Però voi ne avete veramente tantissime di aziende in tantissimi ambiti: dalla lavanderia particolare – mi raccontava il vostro presidente che cerca di mettere umanità e valore aggiunto – fino invece a quelle meraviglie che conosciamo che sono certo un’altra idea (si potrebbe citare un’azienda invece con la K, a proposito di idea di mobilificio) che è legata a dei materiali spesso anche di maggior pregio, ed è l’unità di misura che diceva Antonio Calabrò, cioè fare su misura. Sicuramente il vostro ambito è uno di quelli che più di altri si basa proprio sul concetto di fare su misura, essere un servizio su misura. Mi piacerebbe con te rompere alcuni di quegli stereotipi e anche quelle difficoltà a comunicare, sapere come stanno innovando le vostre piccole realtà che però fanno grande l’impresa, e soprattutto che incontriamo ogni giorno nella nostra quotidianità, cioè, è impossibile non incontrare una vostra azienda nella nostra vita di ogni giorno, per fortuna. E quindi, grazie di essere qui, di darci questo contributo in una forma di rappresentanza, che – io credo molto nei corpi intermedi – reputo particolarmente importante, perché mettere insieme tanti individualismi è il salto che serve anche al Paese, cercare di farli sentire appartenenti a qualcosa di più grande della loro già amata, piccola realtà imprenditoriale.
Francesco Cacopardi: Grazie, Benedetta. Parto proprio da quest’ultima suggestione. Non c’è un momento dove io vada al ristorante, in palestra, in ufficio, in cui non racconti ai miei amici «Ah questo lo fa tizio, questo lo fa Caio, questo lo fa Sempronio», quindi so collocare immediatamente tutti gli oggetti che arredano un determinato contesto, un determinato luogo. È proprio questa la caratteristica dell’Intelligenza Artigiana, come appunto dice questo felice slogan che riprende, ovviamente, l’IA rilanciandola su una dato di realtà che è quello tipicamente italiano. Non ripeterò concetti che chi mi ha preceduto ha espresso in maniera puntualissima e precisa, e che condividiamo al 100%. C’è un primo aspetto di superare quella posizione, come dire, alternativa, del porre il piccolo come nemico del grande e viceversa. C’è una visione un po’ conflittuale della società con una teoria anche economica che contesta dalla mattina alla sera il sistema italiano, dicendo che è troppo piccolo, troppo frammentato, troppo distribuito, e quindi è necessario fare o forzare aggregazioni che puntualmente vengono poi smentite dalla realtà; e viceversa, atteggiamenti rivendicazionisti o esageratamente sindacalizzati del nostro mondo, che in qualche modo vedono il nemico nella grande impresa. C’era un libro, di qualche anno fa, che diceva: «le pulci sono forti e non hanno più bisogno degli elefanti», come Charles Sandy negli Stati Uniti citava questa suggestione, legato alla novità rotta un po’ dalle nuove tecnologie molto distribuite; era legato alla prototipazione rapida piuttosto che a tutto il mondo delle stampanti 3D e in cui sognava, appunto, un mondo dove superava quel triangolo tradizionale di relazioni tra il designer, il produttore e il consumatore, che possono coincidere in una sola figura. Diciamo che la realtà tutte queste esagerazioni le ha sistematicamente smentite, senza nulla togliere alla bontà che ovviamente ogni piccola intuizione portava in gioco. Io ritengo, appunto, che il primo elemento sia proprio questo, cioè il piccolo; ogni grande si porta dietro una filiera e in ogni filiera c’è un piccolo che in qualche modo, se è posizionato bene, dà, come dire il senso, il significato, la direzione all’intera filiera, e questo è la tipicità appunto dell’Italia. Quindi, un sistema di piccola e piccolissima impresa, ma posizionate nei luoghi giusti delle grandi filiere. Quindi, sul fronte non c’è il marchio italiano, il secondo e il terzo sicuramente sì. Dove questa creatività, questa intelligenza trova, come dire, il suo sviluppo nel capitalismo della conoscenza? Lo trova, come appunto diceva il professor Calabrò precedentemente, in un territorio, in un contesto, dove questa familiarità tra le persone trova il suo tessuto connettivo, perché al bar ci si vede, o nelle riunioni varie che si costruiscono ci si vede, ci si parla, ci si racconta, e si trasmette quello che è, appunto, il sapere vissuto, che è la caratteristica primaria del nostro Paese, e per fortuna che ancora questa realtà c’è, perché è l’unica cosa, forse una delle poche, che ci consente di resistere ai grandi investitori che vengono dalla Cina dagli States o dagli altri àmbiti. Ecco, in questa forza credo ci sia la prima componente. Belle, appunto, le osservazioni dell’ex rettore del Politecnico, proprio sull’affrontare la complessità non tanto con una frammentarietà ulteriore, quanto con un senso, un significato che riconnettesse il tutto. In questo senso, credo che possa essere decisivo il nostro ruolo.
Un secondo aspetto – e scendo un po’ di più nel dettaglio come chiedeva Benedetta – riguarda come questa cosa si esprime nella gamma vastissima di imprese. Noi distinguiamo le piccole imprese in tre modi. C’è un primo gruppo che è dentro le filiere in luoghi strategici, che quindi cresce, è cresciuto, non ha avuto momenti di crisi neanche nei peggiori momenti della nostra storia recente, perché appunto c’era un prodotto di assoluta qualità. Il secondo livello è quello invece intermedio, che in qualche modo deve decidere cosa fare da grande, e qui si pone gran parte del nostro impegno, proprio per far crescere la consapevolezza che l’essere imprenditore vuol dire in qualche modo sedersi dietro la scrivania e non essere sempre e soltanto fagocitato dal lavoro e dalle scadenze dell’officina. Credo che quello sia il passaggio proprio logico-tecnico-imprenditoriale che fa di un capoofficina un imprenditore. Questo è un po’ il passaggio decisivo. Ci sono tantissime realtà così, e sono quelle che hanno quella forza che può in qualche modo agganciarsi e sviluppare nuovi scenari che abbiamo sott’occhio, “il prosperare nel caos” , direi. Il salone del mobile è uno di questi momenti dove queste realtà trovano la linfa e la possibilità di potersi rilanciare. Le 4M o le 4A, insomma, che si citava prima, che sono i punti chiave del nostro Paese, appunto, nel settore mobile trovano la loro punta dell’iceberg, tenendo conto però che quello che spesso si trascura nelle cronache è che, perché ci sia un design, c’è dietro un mondo che prende tutti gli àmbiti. Io conosco ovviamente di più la Brianza, ed è cresciuta la Brianza perché è cresciuto il Sistema Brianza, ovvero c’era il bravo falegname ma che aveva dietro anche il produttore di macchine utensili per produrre bene l’oggetto di falegnameria o il mobile d’arredamento, e così in Italia sono cresciuti i distretti. Rimini senza turistica, senza un tessuto dietro che in qualche modo serve tutta la politica alberghiera dell’accoglienza, non sarebbe Rimini, non sarebbe l’Emilia Romagna. Ecco, i grandi distretti italiani sono tali proprio nella misura in cui c’è l’elemento di punta, ma che si porta dietro un sistema multiplo, cioè distribuito su più àmbiti e settori. Ecco il salone del mobile rappresenta questo mondo enorme, che vale metà del fatturato circa dell’anno, perché appunto in quell’occasione ci si confronta con i grandi buyer. Qui uno dei grandi stereotipi da schiodare, che non capiscono le delegazioni estere quando vengono nel nostro Paese, è quello di immaginarsi la piccola impresa come l’attività dell’esperto, del ragazzo che sta a spuntare il pezzo di legno al mercato e a vendere l’oggettino di seconda fascia. Insomma, c’è anche questa componente, ma per noi l’artigianato artistico ha una sua gamma, ha un suo perché, ha un suo significato, ma non è questo l’artigianato del nostro mondo; sono le imprese di grande solidità, di grande esperienza, dove il tempo e la conoscenza fanno proprio quella differenza che citavo prima. Mi raccontava adesso questo giovane, che ha preso da poco le redini dell’azienda, diceva «vedi, mio papà se gli dai un asse, una tavola, ti dice subito se quella tavola va bene o non va bene perché c’è l’occhio, io ancora questa cosa non ce l’ho pur avendo una abilità, per cui a me serviranno due assi per trovare poi il la sedia giusta, insomma quella perfetta che ci chiedono i grandi mercati o i grandi o i grandi Player». C’è poi chi sta sviluppando questa tecnologia che poi è una tecnologia molto banale per certi versi, seppure altamente innovativa (banale nella logica, nella concezione ma innovativa sia nel materiale sia nelle tecnologie che vengono applicate), e che è legata un po’ a tutta la pietra applicata in arredamento. Ecco, tutto questo filone assolutamente innovativo che ha dietro però non la pietra in quanto tale, bensì una pietra sopportata da queste nuove resine tutte bio che consentono all’oggetto di avere poi una praticità e una collocazione ideale. E questo, se vuoi, è un penultimo aspetto che mi interessava sottolineare, quello cioè di offrire con le nostre realtà, anche microscopiche, dei luoghi reali dove il grande architetto trova le soluzioni, perché tanti di noi fanno proprio questa parte finale; cioè la grande idea, se non ha poi un tecnico, un operatore, un pratico che in qualche modo la riduce a quello che poi deve diventare, resta una grande idea, bella forse per scrivere un libro, ma poco funzionale, poco realizzabile. Il che non vuol dire sminuire la bontà e la grandezza di questa idea, vuol dire semplicemente avere quell’occhio, quell’intelligenza applicata – quindi si può utilizzare un’altra terminologia oltre all’Intelligenza Artigiana, un’Intelligenza applicata – che ha dentro di sé quella genialità che caratterizza un po’ il nostro essere. Giotto tutto sommato era un artigiano, quindi aveva una grande bottega artigiana di collaboratori che con lui poi realizzavano le grandi opere. In questo senso, la piccola e piccolissima(impresa) diventa un elemento trainante per certi versi. Ripeto, non ha la forza di collocarsi e di andare a vendere la grande cucina o la grande serie di mobili a un mercato intero, però nella parte di concezione e di sviluppo sicuramente il ruolo è decisivo e determinante. Un’ultima considerazione per restare nei tempi giustamente assegnati. Mi premeva evidenziare quell’aspetto che è il passaggio generazionale. Ecco, questo è un aspetto ovviamente per noi fondamentale. C’è oggettivamente un problema di anzianità della nostra imprenditoria, che ha avuto un grande boom negli scorsi anni. È cresciuta tutta l’età media della popolazione quindi è un fenomeno anche di per sé naturale, però oggettivamente c’è questa conclusione. I periodi di crisi, tutto sommato, semplificano un po’ questo aspetto perché ovviamente, chi ha maturato la pensione, coglie l’occasione per andarsene appena possibile, in modo tale da non dilapidare quello che magari nella vita ha messo da parte. E quindi da questa parte, come dire, c’è un impoverimento, una interruzione nella trasmissione naturale del sapere che, come avevamo detto prima, è decisiva per le nostre realtà. Quindi, questo sicuramente è un aspetto critico. È cambiato il mondo, sono cambiate le esigenze, quindi uno arriva a 65, 70 anni e dice “mi giro un po’ il mondo invece che stare sempre nella mia officina”, quindi assolutamente legittimo e importante, però questo necessita appunto di luoghi e spazi dove poter avere, appunto, questa possibilità di trasferimento, laddove poi i figli non sempre fanno e seguono le scelte del padre o della madre insomma. Anche questo, ovviamente, è un elemento giusto che però pone seri problemi. Ecco, questo aspetto qua, secondo me, è un tema che va studiato, va affrontato. Quindi, vincere le resistenze del padre che dice “ho messo su l’impresa”, adesso dico una battuta, come la regina Elisabetta con re Carlo, ecco, per dire che ha aspettato una vita per diventare re, e però ha vissuto per 70 anni dentro l’ombra della mamma. Ecco, tante volte nelle aziende succede esattamente questo: quindi il padre “sa tutto”, e non consente al figlio di crescere. Ecco, questo è un aspetto critico che va smussato, va studiato, va visto. Ma soprattutto si pone il problema di come lo studio universitario possa effettivamente avere una ricaduta sulla piccola e piccolissima, perché il rischio vero, dove appunto la formazione universitaria è orientata sul grande solo, l’idea di andare nel piccolo impone, come dire, un’idea di essere in qualche modo soffocati. Questa cosa spesso è un elemento che rompe questa continuità, dove invece c’è l’immagine di prima, cioè dell’ingegnere che per 2 anni gira il mondo e poi torna; questa cosa accade tante volte, per cui il figlio giustamente cerca le sue strade, fa le sue esperienze e dopo magari un po’ di lavoro sotto padrone decide di rientrare in azienda, di prenderla in mano e a questo punto la trasforma e la ribalta per come la sua competenza e conoscenza gli consente di fare rispetto magari al papà che lavorava in un ambiente circoscritto. Questi sono alcuni aspetti che osserviamo spesso e che richiedono appunto di confrontarsi, proprio per vedere insieme le possibili soluzioni che non possono che essere diverse. L’errore più grande che si possa fare è di chiudere la questione in due o tre categorie che non corrispondono poi alla varietà e molteplicità della realtà. Certamente è un problema vero, reale e secondo noi strategico per il futuro del nostro Paese. Io mi fermerei qua. Grazie.
Benedetta Cosmi: È vero. Allora, con tempi flash, in questo secondo giro a questo punto chiederei, visto che si parlava dell’università, a te.
Guido Saracco: In modo conciso, mi piacerebbe rispondere alla sollecitazione appena ricevuta. Allora, quello che dicevo prima, cioè l’interdisciplinarità è ormai un prerequisito per tutti. Cioè, anche una piccola media impresa deve digitalizzarsi, deve essere sostenibile, avere economia circolare, attenzione ai consumi energetici alla CO2, deve rispondere a un’esigenza della società con un prodotto che deve necessariamente far evolvere, perché sennò non rimane sul mercato. Quanto dicevo precedentemente sull’ingegnere umanista, l’ingegnere creativo – che sembra un ossimoro ma è tutt’altro che un ossimoro – perché la creatività oramai la si gioca in squadra e porta l’ingegnere che esce, e uscirà sempre di più dalle nostre università, assumere in sé una certa interdisciplinarità che gli consente – perché sicuramente una piccola impresa non può assumere un filosofo, come invece fanno le grandi imprese, anzi ne assumono anche tanti, non può, come dire, assumere esperti necessariamente, dipende un po’ dalle dimensioni di informatica se è un’impresa metalmeccanica, piuttosto che sostenibilità ambientale, economia circolare, eccetera. E allora sono questi ingegneri, che hanno perso i paraocchi e sono talmente verticali da non avere la visione di insieme, che dobbiamo dimenticarci. Nella mia ultima inaugurazione di anno accademico, che è stata una specie di Opera teatrale per riuscire a condensare dei messaggi senza perdere, diciamo così, l’audience, io parlai di me stesso, parlai di quello che provai quando nel 1989 mi laureai in ingegneria chimica. È stato un percorso rapido, ho avuto la possibilità di divertirmi tra virgolette, anche essere più o meno creativo, ma su altri versanti: facevamo i film, andavamo in discoteca a fare le feste tematiche; ero portato, si vede, per quegli studi. Ma ricevetti 39 offerte di lavoro, ovviamente da grandi imprese prevalentemente; mi facevano paura, perché io francamente non ero in grado, non mi sentivo in grado di essere un ingegnere, e alla fine io scelsi di rimanere (mi piaceva anche molto insegnare) nel mio guscio, a fare quello che ho fatto – carriera universitaria, sono stato 30 anni diciamo nel mondo della ricerca, poi ho cominciato a occuparmi di strutture sempre più grosse, fino ad arrivare al rettorato. Ma di nuovo ho sbagliato questo, cioè la fattispecie “laureato specialistico” si riflette in tante, come dire, discipline, in cui vengono incasellati e guai a uscirne, guai a dialogare con gli altri, perché sennò vieni fregato agli esami, ai concorsi, e diventano espertissimi di una cosa, ma francamente, io le posso dire, inadeguati a insegnare una professione. Per questo, due cose: abbiamo fatto al Politecnico una piccola scuola di pedagogia per i docenti perché si abituasse a una didattica meno trasmissiva e più discussa e portassero problemi complessi e facessero lavorare in gruppo le persone e così via, anche nel loro corso; seconda cosa, apertura alla ricerca interdisciplinare, che è quella attraverso la quale ormai si fanno dei passi avanti anche i nuovi prodotti, e inserimento di quei moduli didattici a cui facevo riferimento prima, ma ce n’è uno che non ho detto che potrei concludere il mio intervento con questo: i team studenteschi. Al Politecnico di Torino abbiamo 54 team studenteschi che sviluppano prodotti, servizi, cose innovative anno dopo anno, e che miscelano quelli che stanno uscendo dal tunnel del Politecnico con quelli che vi stanno entrando. Ognuno porta le proprie cose di diverse discipline – l’ingegnere informatico potenziale, l’architetto, il designer, l’ingegnere gestionale, quello di materiali, l’energetico e così via – che concorrono a sviluppare un auto da corsa a idrogeno che va più veloce dell’anno precedente o percorre più strada. 54 cose diverse. Sono bellissime. Purtroppo, abbiamo solo il 15% di studenti che sono coinvolti per questioni proprio di massa, ma bisogna andare in quella direzione, perché questi ragazzi poi, a quel punto, non hanno più paura della piccola impresa che va su un prodotto e per forza ha bisogno di persone più aperte mentalmente, ma magari troveranno anche che è più facile lì, se vali, ottenere una soddisfazione anche economica rapidamente. C’è un problema enorme che avete, penso l’àmbito generazionale in Italia, per cui c’è proprio bisogno di queste persone che entrino nelle imprese e se ne facciano rapidamente carico in questo momento storico. Sto frequentando un po’ di fondi di investimento come consulente, ma questo è un “temone” su cui ci sono grandissimi capitali per andare a intercettare la qualità delle nostre piccole e medie imprese: grandissimo know how e competenza, però di persone anziane che stanno uscendo necessariamente, per motivi biologici, dalla possibilità di gestire un’impresa. Quindi noi abbiamo sentito tutte queste esigenze e spero abbiamo fatto un lavoro, lo si vedrà nei prossimi anni, lo si comincia già a vedere adesso con il successo del nostro ecosistema di innovazione significativo, migliore incubatore al mondo a partenariato pubblico, ESA BIC portato a casa, quintuplicati nostre startup in questi ultimi anni, cioè è percepibile un inizio di un cambiamento importante. Io vi ringrazio, purtroppo devo lasciarvi e mi dispiace molto non poter sentire il secondo intervento di Antonio. Grazie ancora.
Benedetta Cosmi: Grazie ancora. Allora su questi spunti mi viene in mente quando interagisco nei consigli d’amministrazione, adesso ci sono i temi SG, quindi la sostenibilità anche sociale, anche se sembra meno di moda rispetto alla sostenibilità ambientale. Verrebbe voglia di dire che forse si potrebbero creare, appunto, più gemellaggi, per esempio adottare – come a volte si adotta uno studente, si adotta un tesista. Immaginate di adottare una piccola azienda, sia startup ma anche artigiane. Cioè, se il Welfare che è in capo alle grandi aziende spesso è un Welfare anche che collabora con il welfare territoriale, oltre che quello aziendale, possa includere in questo suo ecosistema anche le piccole e imprese che in zona ci sono, perché questo potrebbe anche dare alle nuove generazioni l’impressione di non decadere verso il basso da quel punto di vista, e sappiamo che la maggior richiesta che si fa è comunque legata proprio al Welfare ultimamente, e quindi a certi servizi, dall’asilo nido ad altre esigenze. Quindi, probabilmente quando tu, Antonio, parli giustamente di capitale umano, e subito ci leghi il capitale sociale, parli delle comunità, mi verrebbe voglia di dire, perché non attiviamo in modo istituzionale, nel senso non di uno spot una tantum, che pure esistono grandi eccezioni, e quindi anche grandi eccellenze, ma una sorta di comunità di impresa che quindi si fa carico anche di chi c’è intorno, un po’ come se vedesse queste potenziali botteghe e quindi diventassimo di nuovo queste città, come si può dire, rinascimentali. Questo, allora, potrebbe riavvicinare giovani, talenti, capacità, imprenditori, ma anche gli ingegneri che dicevamo, e quindi restituire, anche avvalendosi di quella interessante cosa che si diceva sul trovare le soluzioni. Cioè, il grande architetto trova la soluzione frequentando, come negli aneddoti che ci raccontava anche il nostro rappresentante di Confartigianato. Quindi, si può creare questa comunità di imprese dove la grandissima mette al suo servizio la scuola di formazione, insomma questa interazione. Anche perché la scuola pubblica, ma anche quella privata, però in generale, rischia di riportarci a un contesto di didattica frontale che ci fa perdere quella capacità fresca, che invece abbiamo sentito avere, diciamo, nei panni del padre, che probabilmente è fermo spesso alla licenza elementare, quindi probabilmente quelle competenze a cui il figlio non è ancora arrivato non le ritroverebbe neanche in una scuola, dovrebbe rifrequentare “gomito gomito”, comi si diceva una volta.
Antonio Calabrò: Guarda, non credo che sia un problema di buona volontà e neanche di mecenatismo. Ci credo poco. Credo al sistema delle convenienze e delle opportunità, partendo se vuoi anche semanticamente dalla parola “competitività”, che è fatta da due parole. La prima è cum, che sta per insieme e l’altra è petere, avere un progetto comune di sviluppo. Allora, i sistemi Welfare di territorio, i rapporti tra piccole, medie e grandi, stanno dentro una convergenza di interessi economici, di progetti economici, lungo le catene di fornitura, lungo le filiere. Io credo che il ragionamento vada fatto sulle filiere e sulle reti. Convenienza delle grandi è che le piccole della loro fornitura, le piccole e medie la loro fornitura, siano per esempio perfettamente in regola con le logiche, con i valori e con le prescrizioni della sostenibilità, perché io devo essere in grado di potere certificare la mia catena di produzione. Lo chiedono i mercati, lo chiede buona parte della finanza. La responsabilità dei grandi è avere una serie di stimoli per potere fare crescere, sia sul versante della transizione, della sostenibilità sia ambientale che sociale, sia sul versante della transizione digitale, tutti i fornitori, piccoli grandi e medi che hanno a che fare con me. Non posso avere il meglio del Made in Italy se ci sono le ombre del sottoscala della subfornitura, per essere espliciti.
Benedetta Cosmi: Sembra anche un riferimento all’attualità recentissima però, purtroppo, attualità permanente.
Antonio Calabrò: È assolutamente generale. Così come, dentro la mia catena di fornitura, io grande ho uno straordinario interesse su un valore, che è quello della sicurezza sul lavoro. Ora, i dati sulla sicurezza del lavoro nel Paese non sono confortanti. Qui penso al disastro ieri in Emilia, e credo che sia interesse delle piccole imprese uscire fuori dalla percezione del sommerso, dalla percezione del nero, dalla percezione delle irregolarità, e non soltanto perché ci sono leggi da rispettare e valori da rispettare. Il lavoro è un valore, il lavoro è una dignità. Ha ragione il Presidente della Repubblica Mattarella quando, seguendo l’onda dei presidenti precedenti – penso alle cose dette da Ciampi, Napolitano – ribatte punto per punto sul lavoro come dignità, sul lavoro come sicurezza,, sul lavoro sulla qualità del lavoro e sulla sicurezza del lavoro come un elemento fondamentale della catena produttiva. Noi facciamo cose belle che piacciono al mondo, in modo sicuro e in modo trasparente: stanno insieme. Non puoi avere il su misura, la qualità, il design, la bellezza, l’innovazione se dietro c’è un elemento della morte, della ferita, della frattura; e questo è un punto fondamentale che riguarda tutta l’intera la Filiera. Le grandi in questo hanno una straordinaria responsabilità. Ci sono grandi – penso alla Ima di Vacchi, in Emilia, che assume partecipazioni lungo tutta la sua catena di fornitura nelle piccole aziende che stanno lungo quella catena di fornitura, perché da azionista ne controlla il processo. Non so se sia il sistema migliore, ma è sicuramente un sistema di grande interesse. E in ogni caso, il meccanismo certificazione, anche rispetto alla Finanza, rispetto all’ingresso nel capitale da parte dei fondi di investimento, ha molto a che fare con la certificazione della qualità, della del rispetto dei principi SG, che riguardano l’ambiente, che riguardano il dato sociale, che riguardano la governance. Questo è un tema di governance, la governance della filiera, la cui responsabilità sta in capo ai grandi. La seconda osservazione che vorrei fare, e chiudo, ha a che fare col passaggio generazionale che è un problema molto complesso. Io so bene come, per chi ha fondato un’impresa, quell’impresa sia parte essenziale di sé, sia un pezzo fondamentale della propria identità, e questo è un vantaggio enorme del capitalismo familiare con un senso della storia. Il capitalismo manageriale è rapido: si entra in azienda, si fanno dei percorsi, si esce: non è mia. Il capitalismo familiare guarda progetto di lungo periodo nel corso della storia. Il meglio che questo paese può esprimere è l’innesto del capitalismo familiare azionario con la capacità di gestione manageriale delle competenze, che vengono messe in campo prendendole là dove il mercato offre.
Benedetta Cosmi: Che esempi ti vengono, che esempi si possono citare?
Antonio Calabrò: Una lunga serie di imprese. Zambon farmaceutica, per dirne soltanto una, ma ne potrei elencare un’infinità. So che questo problema della managerialità è un problema aperto per le imprese artigiane e per le piccole e le piccolissime. Si potrebbero pensare figure di competenze manageriali consortili: l’export manager per 10 imprese dello stesso territorio.
Benedetta Cosmi: Esiste qualche esempio già reale o ancora siamo nella fase della proposta?
Antonio Calabrò: Sui territori produttivi ci sono parecchi esempi del genere, non moltissimi, ma è una figura che va avanti. La stessa Brianza delle piccole e piccolissime imprese di subfornitura del mobile, dove ci sono non soltanto i prodotti del legno, della plastica, ma ci sono per esempio le cerniere. La metalmeccanica brianzola tiene in piedi l’industria del mobile. Uno sportello lo devo potere aprire: quella capacità metalmeccanica che ha anche un elemento di bellezza, le nostre cerniere sono funzionali e belle, più belle di quelle tedesche, spesso funzionali come le tedesche. Insomma, gli export manager condivisi, ma anche i manager della sostenibilità, ma anche così via continuando, cioè bisogna pensare le piccole imprese, che da parte del fondatore sono mondi chiusi (mio, protetto), come strutture aperte. Perché l’essere struttura aperta, avere una cultura aperta, consente per esempio un’operazione fondamentale: il passaggio generazionale ha bisogno di formazione, e ha bisogno di finanza. Altrimenti, non passa di mano l’azienda, anche parzialmente non si trasforma, non ha i capitali per potere liquidare i membri della famiglia che volentieri uscirebbero, perché fanno altri mestieri, fanno il medico o hanno aperto un negozio, oppure insegnano all’università, oppure hanno un villaggio turistico oppure sono impiegati in un’altra realtà. I soci devono poter essere liquidati. L’ingresso di Finanza dentro le piccole imprese, anche le piccole imprese artigiane, ha bisogno di avere, però, una cultura aperta, della dialettica, del confronto, della trasparenza da parte dell’imprenditore, dell’imprenditrice fondatori. Ecco, questi sono i temi che abbiamo davanti. Io credo che ragionare di politica industriale non significhi soltanto ragionare di fiscalità, significa ragionare anche di cultura di impresa.
Benedetta Cosmi: Questo già sarebbe un bel titolo. Mi piace che è in parte anche un’autocritica, nel senso che a volte sembra che si sia accettati di essere scaraventati in quel ruolo e quindi chiamati a dover dare una proposta, una risposta; ci si posiziona e quasi si muore su quell’unico aspetto, mentre poi rimangono invece aperte tutte le altre. Allora, chiudiamo anche con te in modo breve, possiamo dire che oggi, con una provocazione, è più facile diventare medico che diventare, non so, falegname o addirittura altri nomi che trovo anche difficile reperire nel grandissimo mondo che tu rappresenti e studi. Questo perché nella formazione ci è più chiaro il processo per diventare medico – con tutti i limiti, le difficoltà e abbiamo visto anche la questione del passaggio poi dalla facoltà alle specializzazioni, quindi il blocco che per anni e c’è stato e che oggi paghiamo in termini di carenza di personale sanitario – però la difficoltà di diventare, non so, falegname, è enorme perché in quale scuola mi dovrei scrivere? In quale territorio c’è quella scuola? C’era un mio corsivo del Corriere che diceva “Studiare greco e falegnameria”. Ovviamente, oggi, in Italia è impossibile. A te, Francesco.
Francesco Cacopardi: Qualche eccezione piccolina c’è, quindi si può studiare greco con la falegnameria. Un preside, che poi purtroppo è morto, recentemente aveva messo in piedi questa rete delle scuole professionali del legno, sono 22 in Italia quelle rimaste, e poi ci sono tante realtà invece locali, appunto; in Brianza ne abbiamo tre di queste realtà. Lì il problema, però, sono le vocazioni, cioè la gente non si iscrive, per cui c’è un problema proprio di cultura per spiegare alle famiglie che vale la pena scommettere su lavori dove uno magari realizza i suoi talenti e le sue doti, magari è più contento perché non deve stare dietro la scrivania tutto il giorno, per cui questa cosa è un problema proprio culturale. Io dico sempre che bisogna inventarsi una trasmissione televisiva perché il Masterchef della situazione ha sdoganato il lavoro da cuoco, che prima era reietto e che è diventato un Cult del nostro Paese. Ecco, se riusciamo a trovare qualche trasmissione anche sulla falegnameria, la meccanica, eccetera, sarebbe un colpaccio. Questo te lo do come suggerimento, Benedetta, che ti occupi di comunicazione. Io riprendevo due cose soltanto. La prima, la domanda tua sull’Export manager, come suggeriva il professore prima; ecco gli esempi su questo noi siamo molto favorevoli ai contratti di rete, sono strumenti nuovi, relativamente nuovi perché ormai sono un po’ di anni che ci sono, ma secondo me coniugano quei due aspetti che appunto prima suggerivo, cioè la naturale ritrosia a essere dipendente tipico del lavoratore autonomo – è autonomo proprio perché ha un impeto di libertà che vuole difendere a tutti i costi, quindi naturalmente individualista da questo punto di vista perché altrimenti farebbe un altro mestiere. Quindi, mettere insieme più teste è sempre critico; nella misura in cui, però, io faccio prevalere l’interesse collettivo (ovviamente nessuno è stupido sa bene che mettendosi insieme si acquisiscono commesse che altrimenti non porteresti a casa, banalmente), quindi mettendo insieme più soggetti con obiettivi e scopi precisi, dove però ciascuno continua a aver garantita la sua autonomia, secondo me sono sistemi giusti, che coniugano e trovano il giusto equilibrio tra queste due esigenze: l’autonomia e, nello stesso tempo, i vantaggi delle economie di scala e di sistema. In questo senso l’Export manager che citava può essere sì finanziato, e reti da questo punto di vista ce ne sono molte, sono cresciute e credo che sia una direzione se – e qui mi permette una battuta cattiva – lo Stato lascia fare, non si mette di mezzo per irrigidire ulteriormente questa dinamica, riducendola a quello che sono i consorzi, per esempio, che hanno una loro genesi partita da questo punto di vista, ma che poi si sono ingessati e hanno una durata molto rapida, perché durano il tempo di prendere la commessa, ma poi raggiunta la commessa si riprende a litigare, quindi la durata media è di 3-4 anni. Dopodiché i consorzi saltano, perché c’è questa dinamica troppo rigida. Qui mi permetto una seconda osservazione, riguarda negli scenari accennati sui quali si giocano un po’ le prossime sfide. Si citava appunto l’Unione Europea; ecco, qui secondo me c’è una idea di poter creare un sistema perfetto con norme perfette. Ovvero l’assunto che, se ho un sistema certificato poi nei vari livelli, quindi lo prendo come affermazione generale, in qualche modo poi, automaticamente, tutto il sistema funziona. Ecco, io su questo ho molte perplessità, molti dubbi come approccio. Se andiamo anche a trattare l’Intelligenza Artificiale, una piccola analogia potrebbe essere la differenza tra Intelligenza Artificiale e la Robotic Process Automation l’RPA cosiddetta, sono due mondi totalmente diversi, perché uno lavora sull’automazione delle azioni umane – l’Italia è leader perché siamo terzi in Europa su queste applicazioni – l’Intelligenza Artificiale, invece, che si applica sul funzionamento e simula il funzionamento del cervello presuppone ha un avanzamento decisamente diverso, ma il suo limite è che deve essere perfetta nella sua concezione, nella sua costruzione. Ma probabilmente la crisi del 2009 deve essere conseguenza di qualche algoritmo nella quale determinate categorie o possibilità erano di fatto non previste. Credo che adesso, dando questa piccola immagine che forse può servire, nel primo ambito si gioca la nostra partita proprio di sistema, su quella caratteristica che quindi è capace di muoversi perché, come dire, prende tutto, cioè è capace di assorbire tutto senza dover irreggimentare questo tutto, lo prendo nelle sue forme, nei suoi modi, nei suoi modi molto creativi, diversi, di ambiente, di linguaggio, di tecniche, di applicazioni, e in qualche modo gli dà un ordine finalizzato. Questo credo che sia proprio la tipicità italiana, quella della sinfonia, più che della massa. La sinfonia, dove ogni artista fa il suo pezzo, lo fa bene, c’è un bravo maestro che mettendo insieme tutto rende un sistema armonico. Ecco questo credo che sia il ruolo, deve partire dal basso non parte dall’alto, su questo sono assolutamente convinto. Partendo dal basso, invece, è valorizzato nel modo giusto, io credo che crei quelle due realtà che sono tipiche del nostro Paese, benessere e coesione sociale. Stupisce lo straniero andare nella piccola azienda e vedere nel box di casa magari la Ferrari, “ma com’è sta storia che questo qua ha un’azienda di cinque persone e ha la Ferrari nel box”, questo non lo capiscono perché per loro la dimensione sta col benessere. Ecco, da noi c’è questo benessere diffuso che consente proprio questa capacità, che nasce da questa grande intelligenza di relazioni e di rapporti e di finalizzazione a quelli che sono gli obiettivi poi che sono interessanti per tutti. Potrei aggiungere un’ultima battuta sulla miniaturizzazione, laddove si fa fatica a dialogare con l’università, perché è evidente che se io ho come cliente l’Ima citata prima, ho ovviamente un uno staff e un team che può lavorare su più fronti e con investimenti anche più sostanziosi. La piccola non ce l’ha questa forza, però ha la stessa esigenza, perché anche il piccolo, lavorando nella filiera, chiede altissima specializzazione. Poi, evidentemente, la dimensione non coincide con l’investimento che è necessario per avere questa altissima specializzazione, però se troviamo la chiave di lettura che consenta e renda economicamente interessante questo aspetto, questo può generare veramente una grande spinta a quel rinnovamento del nostro tessuto produttivo che è richiesto. Io ho visto qui esperienze interessantissime, dall’azienda Metalmeccanica molto specializzata sulle grandi dimensioni, dato che il mercato da quella parte non tirava, si è messo a fare le protesi dei denti, per cui la stessa tecnologia applicata al grande l’ho applicata al piccolo, e sono diventato leader nel piccolo, cioè, ho miniaturizzato quello che m’arriva dal grande. Io questo credo che sia una bella frontiera, come, viceversa, il dialogare tra settori diversi. Ricordo questo contratto di rete realizzato da queste imprese del mobile, al quale abbiamo abbinato per ragioni più normative, cioè c’era un finanziamento da prendere, all’ultimo momento era mancato un partner, abbiamo preso questo che si preoccupava di costruire ippodromi in giro per l’Europa, ed ecco che la combinata ha creato Le stalle dello Sceicco che vengono vendute a prezzi stratosferici, perfettamente in linea con un hotel di lusso, per cui se nella stalla normalmente uno ci va con gli stivali sporchi, qui cammina sui marmi. Queste sono un po’ le piccole possibilità che, secondo me, questa dinamica introduce.
Benedetta Cosmi: Bene. Mi piace molto l’espressione che vorrei sintetizzare con “la chiave dell’esigenza”. Nel mondo del lavoro, dove si parla di domanda, offerta, difficoltà a fare incrociare il mismatch, eccetera, la chiave dell’esigenza può essere la svolta. E allora auguro a voi buon Salone del mobile, e anche buon Fuori Salone con questa avvertenza: nell’ultimo anno ci eravamo iniziati a preoccupare perché stava per diventare più uno spettacolo, il messaggio delle tante persone in fila per entrare, accedere a guardare non mi era piaciuto lo scorso anno; al di là della scomodità, del caos che si crea in città, ma viene meno quella sensazione di appartenere a un mondo produttivo. La città di Milano si presta molto a essere la città del lavoro, non vorrei che diventasse la città, invece, del mordi e fuggi, di chi viene a vedere come se fosse un banale Colosseo oggi a Roma, e domani il Salone del mobile a Milano, perché rischierebbe di perdere questa occasione proprio di rete che voi avete, con queste suggestioni, fatto a noi assaporare.
E invece mi piacerebbe che potesse diventare un posto dove forse anche i giovani, eventuali, potenziali nuovi talenti, venissero a incontrare le tante aziende di questa filiera che hanno contribuito a creare questi oggetti bellissimi, che saranno presenti, esposti e che insomma arricchiranno e animeranno un po’ la nostra città, proprio cercando di imparare dei nuovi mestieri. Magari scoprono di poter far parte, con come dici tu; a volte ancora neanche esiste il prodotto che si deve realizzare, ne hai citato uno dove se lo sono inventati, quindi ecco, venite a frequentare Salone, Fuori Salone, ancora come soggetti attivi del mondo del lavoro, non soltanto come se andassimo al cinema a vedere un film. Spero siate d’accordo anche voi; insomma, buono spettacolo, in un certo senso, ma dall’altro, grazie a chi lo farà, a chi saprà trovare nuovi stimoli anche da questa nuova, e ormai alle porte, edizione. Grazie per aver partecipato, di aver contribuito al dibattito, al Laboratorio. Ringraziamo anche chi ci ha seguiti fino a adesso. Grazie ancora, e buon lavoro.