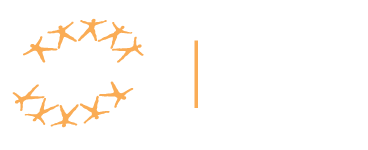Agromafie
3° Rapporto sui crimini agroalimentari in Italia
Documento di Sintesi
CAPITOLO 2 | Italia, Europa e scenario internazionale
Il Sistema di allerta rapido per alimenti e mangimi. Il RASFF (Rapid Alert System for Food and Feed) è stato istituito per fornire un efficace strumento di scambio delle informazioni sulle misure adottate in risposta all’individuazione di rischi alimentari.
Nel 2008, il RASFF è stato messo alla prova in seguito a una lunga serie di episodi in materia di sicurezza alimentare: olio minerale presente nell’olio di semi di girasole proveniente dall’Ucraina (39 paesi interessati, 99 notifiche di follow up); in alimenti provenienti dalla Cina si è scoperta la presenza di melamina (incidente con impatto globale, 84 notifiche RASFF e 101 notifiche di follow up) mentre nella carne di maiale proveniente dall’Irlanda si sono trovate tracce di diossina (54 paesi interessati e 230 notifiche).
Nel 2013, il sistema ha trattato 3.136 notifiche (di cui 65 sono state successivamente revocate), con una diminuzione del 8,7% rispetto all’anno precedente. In particolare, 2649 notifiche hanno riguardato l’alimentazione umana, 262 l’alimentazione animale e 225 la migrazione di materiali destinati a venire a contatto con gli alimenti. Le principali irregolarità sono state riscontrate nei prodotti della pesca, nella frutta e vegetali, nella frutta secca (principalmente per micotossine, attraverso respingimenti della merce ai porti), e nella carne escluso pollame. L’intensa attività di controllo condotta sul nostro territorio è testimoniata dalle 534 segnalazioni inviate (il 17% del totale) al sistema.
Le carenze della legislazione europea. La libera circolazione delle merci tra gli Stati Membri dell’Unione europea costituisce uno strumento essenziale per realizzare il mercato interno previsto dall’articolo 3 del Trattato dell’Unione Europea (TUE) (Sbolci, 2010).
Il mercato interno, come meglio definito dall’articolo 26, par. 2 (ex art. 14, par. 2, TCE), comporta uno spazio senza frontiere interne nel quale è assicurata la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali.
Anche gli atti normativi adottati dall’Unione europea per armonizzare le legislazioni nazionali contribuiscono a sopprimere le barriere al commercio intracomunitario create dalle divergenze delle legislazioni degli Stati membri.
Le disposizioni che producano effetti diretti prevalgono su ogni norma nazionale eventualmente confliggente. Questa prevalenza implica la disapplicazione delle norme interne contrastanti con le disposizioni dell’Unione. La libera circolazione, in pratica si applica alle stesse condizioni per tutte le merci che circolano all’interno dell’Unione, anche quelle che provengono da paesi terzi, ad eccezione di quelle che presentano rischi per i consumatori, la salute pubblica o l’ambiente. Anche in questo campo, vale il principio dell’armonizzazione delle norme tecniche esistenti negli Stati membri ed è indispensabile per eliminare numerosi ostacoli agli scambi comunitari di merci.
In passato, ogni Stato membro imponeva diverse specifiche tecniche a tutti i prodotti industriali, ma le diverse normative tecniche nazionali ostacolano inevitabilmente la libera circolazione delle merci all’interno del mercato unico.
A dar maggior importanza al concetto di mercato interno europeo, concorre il principio del reciproco riconoscimento che garantisce la libera circolazione delle merci e dei servizi senza dover ricorrere all’armonizzazione delle legislazioni nazionali.
Uno Stato membro non può vietare la vendita sul proprio territorio di un prodotto legalmente fabbricato in un altro Stato membro, nemmeno qualora le prescrizioni tecniche o qualitative differiscano da quelle imposte ai suoi prodotti nazionali. È possibile derogare a tale norma soltanto in condizioni molto rigorose, adducendo imperativi d’interesse generale quali la salute, la protezione dei consumatori o dell’ambiente.
La libera circolazione dei prodotti agricoli è generalmente assicurata dalle norme speciali sulla politica agricola dell’Ue che istituiscono organizzazioni comuni di mercato in determinati settori della produzione. Ai prodotti agricoli eventualmente non contemplati da queste norme, sono applicabili le regole generali sulla libera circolazione delle merci.
Il principio di sussidiarietà, però, non è esente da problematiche; un dei punti critici è la disponibilità di informazioni affidabili necessarie per la valutazione. In base ai dati disponibili, una stima precisa della portata economica del reciproco riconoscimento non è possibile, ma è chiaro che il principio è un meccanismo assai importante per numerosi settori dell’industria e dei servizi.
Attualmente, non esistono statistiche sui casi in cui i produttori hanno preferito conformarsi ai requisiti di un paese o rinunciato a commercializzare i loro prodotti.
In base ai risultati delle ricerche condotte nel settore industriale, sussistono ancora degli ostacoli a livello di norme e regole tecniche.
Inoltre: in materia di protezione dei consumatori, lo svolgimento di controlli non è sempre necessario nei paesi di destinazione; nell’organizzazione interna delle Amministrazioni, ritardi amministrativi, procedure costose e incapacità a gestire situazioni complesse (per esempio in merito a prodotti o servizi innovativi) ostacolano una gestione più efficiente; persiste una mancanza di fiducia reciproca rispetto agli atti approvati dagli altri Stati membri.
Gran parte delle difficoltà riguardano i livelli di protezione, poiché spesso in questi casi lo Stato membro di destinazione è persuaso che il modo migliore di proteggere l’interesse generale sia quello da esso raccomandato; facile, a questo punto, intuire come il settore più colpito possa essere quello dei prodotti alimentari.
La difesa commerciale. Il WTO consente agli Stati l’applicazione, in certe circostanze, di misure di difesa commerciale per fronteggiare le pratiche sleali degli esportatori stranieri. Si tratta, in particolare, delle disposizioni relative all’antidumping e quelle destinate a proteggere i produttori nazionali contro i beni importati che hanno goduto, nel paese di origine, di aiuti statali.
Il dumping (che, per l’accordo specifico allegato alla WTO, consiste nell’esportazione di un prodotto a un prezzo inferiore rispetto a un valore normale, che si identifica, di norma, con il prezzo del bene nel mercato di origine) non è vietato dalla WTO; esso è, invece, considerato scorretto da parte degli Stati nazionali, che, quando ne verificano l’esistenza, hanno la possibilità di applicare dazi aggiuntivi nei confronti dei prodotti per i quali un’inchiesta ha stabilito l’esistenza del dumping e il danno per l’industria nazionale.
L’accordo antidumping, dunque, sottopone a regolamentazione il comportamento dello Stato importatore al fine di evitare che la pratica dell’antidumping si trasformi da misura di difesa commerciale in vera e propria pratica di natura protezionistica.
L’accordo sulle sovvenzioni regola sia gli aiuti pubblici degli Stati a favore delle imprese, sia le misure difensive applicabili dagli Stati importatori nei confronti di beni che hanno fruito, nello Stato di origine, di sovvenzioni pubbliche.
L’accordo distingue i sussidi in tre categorie: i sussidi proibiti (quelli all’esportazione e quelli vincolati all’impiego di componenti di origine nazionale); i sussidi passibili di azione legale (tutti quelli che sono suscettibili, fra l’altro, di provocare danni all’industria importatrice); i sussidi consentiti (che, tuttavia, in seguito al mancato accordo fra gli Stati della WTO, sono compresi nella seconda categoria citata).
La Cina e il WTO. L’entrata nel WTO della Cina ha implicato per Pechino l’avvio dell’apertura del proprio mercato ai beni e servizi dei paesi membri, incrementando così anche le sue opportunità di esportazione.
La Cina, nonostante l’impegno a rinunciare ai sussidi all’export, ha cercato, e cerca ancora, di essere considerata ancora come “developing country”, per avere maggiori margini nella concessione dei sostegni alla sua produzione agricola (fino al 10% del suo valore).
Gli Stati Uniti hanno richiesto un limite del 5% (destinato ai paesi industrializzati) e un articolato compromesso è stato raggiunto, posizionato tra il 7 e l’8,5 % del valore della produzione, in dipendenza dei prodotti e delle aree coltivate. L’accordo con l’Ue, che riprende ed amplia quello con gli Usa, conferma l’auspicio che la Cina possa progressivamente eliminare le proprie barriere al commercio ed agli investimenti internazionali.
L’impatto di una progressiva liberalizzazione all’importazione di prodotti agricoli potrebbe condurre a pesanti conseguenze sulle campagne cinesi, dove ancora vive l’80% della popolazione del paese.
Ma per le aziende italiane si aprono notevoli vantaggi dalla riduzione delle barriere tariffarie, dalla creazione di una rete distributiva efficiente, dalla speditezza nel registrare uffici di rappresentanza, dall’implementazione più compiuta del “rule of the law”.
Le concessioni negoziate dall’Ue saranno infatti importanti soprattutto per le riduzioni daziarie. Esse hanno riguardato 150 prodotti industriali, per i quali c’è stato un abbattimento di circa l’8% (più precisamente la media dei dazi si è abbassata dal 18,6 al 10,9% ad valorem); i prodotti agricoli, difatti, hanno rilevato un analogo miglioramento. Il dazio sul vino è sceso dal 65 al 14% e quello sulla pasta dal 25 al 15%.
Soprattutto nel macrosettore dei beni di consumo è possibile una presenza più consistente del Made in Italy. Si tratta comunque di vantaggi concessi anche ai paesi concorrenti e che, se non affiancati da impegni aziendali specifici, potrebbero lasciare l’andamento delle esportazioni italiane in Cina a fattori ciclici e non ad una effettivo radicamento nel paese.
Allo stato attuale, l’Italia si configura come il quinto partner commerciale della Repubblica Popolare Cinese: basti pensare che tra il 1979 ed il 2003, sono stati oltre 2.000 i progetti sviluppati da imprese italiane in Cina, per un valore contrattuale totale di circa 4 miliardi di dollari.
Il land grabbing: la Cina alla conquista dell’Africa. In pochi anni, la presenza della Cina in Africa è passata da argomento per analisti di geopolitica a tema centrale nell’agenda internazionale e nella vita quotidiana del Continente. Il commercio bilaterale tra le due aree è cresciuto, tra il 1980 e il 2005, di oltre il 50%, passando da 10 a 55 miliardi di dollari tra il 2000 e il 2006 e potrebbe sfiorare i 100 miliardi nel 2010.
I governi africani sembrano d’altra parte favorevoli ad accogliere le compagnie cinesi, in modo da creare una sorta di bilanciamento rispetto alla storica situazione di dominio delle compagnie occidentali sulle risorse africane.
Hu Jintao, ex Segretario Generale del Partito Comunista Cinese, in occasione di un incontro con i leader africani tenuto nel 2012, nel corso del suo mandato, ha garantito un prestito di 20 miliardi di dollari, da erogarsi nel futuro, per lo sviluppo delle infrastrutture e dell’agricoltura africana. Cifra raddoppiata rispetto a quella offerta nella medesima conferenza del 2009, a segnalare come la Cina stia proseguendo nella sua politica di “aiuti senza condizioni” ai paesi del Continente nero, con lo scopo di legare a doppio filo le economie degli stessi, assicurandosi contemporaneamente un’ingente parte delle risorse alimentari dell’intero pianeta.
Un altro dato va evidenziato: nella Repubblica Popolare Cinese vive circa il 21% della popolazione mondiale, mentre i suoi terreni coltivabili costituiscono solo il 9% di quelli disponibili sulla Terra. È evidente quindi che una delle necessità più pressanti per la Cina è quella di garantirsi terreni coltivabili, per produrre generi di prima necessità e, rincorrendo l’obiettivo dell’autarchia alimentare, ridurre al massimo la dipendenza dalle importazioni, soggette alle fluttuazioni dei mercati. Il nuovo Far West, da questo punto di vista, sembra dunque chiamarsi Africa.
Nell’ultimo decennio, gli aiuti cinesi al Continente Nero sono aumentati esponenzialmente, ma non certo in maniera disinteressata. Secondo un Rapporto stilato da Coldiretti nel 2011, il giro d’affari è passato da 11 miliardi di dollari nel 2000 a quasi 90 nel 2009 e si stima che le linee di credito delle banche cinesi nei confronti di Angola, Guinea Equatoriale, Gabon, Nigeria, Repubblica del Congo ammontassero a circa 19 miliardi di dollari nel 2007.
Sempre secondo Coldiretti, l’estensione di terreni direttamente acquistati per scopi agricoli corrisponderebbe a circa tre milioni di ettari, ossia una superficie pari al Lazio e all’Abruzzo messi insieme.
La pratica del land grabbing, ovvero l’accaparramento di terreni agricoli da parte di Stati stranieri, è stata condannata dalla stessa FAO perché sottrae le risorse primarie dei paesi interessati, che, quasi sempre, si trovano in condizioni di difficoltà economica, e perché molto spesso un aumento degli investimenti non corrisponde a una maggiore occupazione per le popolazioni autoctone, né a un miglioramento delle loro condizioni di vita.
Recentemente a Durban, il primo ministro dell’agricoltura sudafricano, Tina Joemat-Pettersson, ha duramente attaccato «i paesi stranieri che acquistano terre agricole in Africa per assicurarsi il loro approvvigionamento di cibo. Essi sono colpevoli di una nuova forma di colonizzazione».
Ha fatto poi l’esempio del Sudan, in cui «circa il 40% delle terre sono già state vendute a interessi stranieri. Portano la loro manodopera, portano il proprio materiale, le loro sementi, utilizzano il suolo del paese ospite e dopo se ne vanno».
Finanziamenti per la promozione del comparto agroalimentare. La Commissione Agricoltura (Comagri) del Parlamento europeo è riuscita ad estendere le nuove misure proposte dalla Commissione Europea per sponsorizzare la commercializzazione dei prodotti agroalimentari europei anche all’interno del mercato unico Ue, visto che in un primo momento erano state previste azioni eccezionali solo per il mercato extraeuropeo (tra il 2001-2011 solo il 30% del bilancio destinato alle azioni di informazione e di promozione riguardava i mercati dei paesi terzi) (www.agronotizie.it).
Più fondi Ue per campagne promozionali e promozione del Made in Europe. Le azioni mirate a promuovere la commercializzazione dei prodotti agroalimentari dei 28 paesi, anche al loro interno, potrà contare su un finanziamento europeo del 70-80% contro il 50-60% originariamente proposto.
Nel caso si verificassero severe crisi di mercato, come nel caso del cocomero spagnolo e dell’infezione E. Coli, il finanziamento Ue potrà raggiungere l’85% del totale con un eventuale ulteriore 5% se il richiedente appartiene ad un paese in difficoltà finanziaria.
Nello specifico, la Commissione Europea definisce i fondi europei strutturali agricoli come un quadro giuridico che permette il finanziamento della politica agricola comune PAC.
Il nuovo strumento prevede uno stanziamento di risorse composto da un aumento graduale durante il settennato.
Si passerà dai 61,5 milioni di euro del 2013 ai 200 milioni di euro del 2020. I contributi comunitari corrisponderanno: al 70% della spesa ammissibile per i programmi semplici da realizzare nel mercato interno; all’80% della spesa ammissibile per i programmi multipli da realizzare nel mercato interno e per tutti i programmi nei paesi terzi; all’85% della spesa ammissibile in tutti in casi di crisi, senza distinzione tra programmi semplici e multipli.
Una delle maggiori novità introdotta nei finanziamenti diretti è costituita dall’introduzione di una componente obbligatoria. A questa verrà conferito ogni anno non oltre il 2% del plafond nazionale. Gli Stati membri dell’Unione europea saranno chiamati a fornire un pagamento annuo per i giovani beneficiari nel campo del regime di pagamento di base.
La nuova PAC 2014-2020 impegna il nostro Ministro delle Politiche Agricole ad una programmazione per lo stanziamento complessivo di 52 miliardi, 27 di questi sono pensati come aiuti diretti del I Pilastro (pagamenti diretti). Altri 21 miliardi di euro sono progettati per finanziare le misure del II Pilastro (lo sviluppo rurale), in questo caso il finanziamento è reso possibile da fondi europei e dall’Italia. Si devono inoltre considerare i finanziamenti dell’OCM (Organizzazione Comune di Mercato), corrispondenti a circa 4 miliardi di euro. Ulteriori incentivi all’agricoltura si trovano all’interno del “Decreto Competitività”, dove sono stati inseriti nuovi crediti d’imposta e altre semplificazioni per sostenere il settore agroalimentare con particolare riferimento all’utilizzo di nuove tecnologie da parte delle PMI agricole.
Le imprese del settore agricolo fruiscono inoltre di un credito d’imposta del 40% sulla spesa compiuta per infrastrutture informatiche volte al potenziamento del commercio elettronico.
Transatlantic Trade and Investment Partnership. Il TTIP, i cui negoziati hanno avuto inizio nel luglio 2013, è per ora una semplice dichiarazione d’intenti.
L’accordo di libero scambio fra Usa e Ue dovrebbe portare alla nascita di un «partenariato trans-atlantico per il commercio e gli investimenti (…) un accordo commerciale che è attualmente in corso di negoziato tra l’Unione europea e gli Stati Uniti».
Questo ha «l’obiettivo di rimuovere le barriere commerciali in una vasta gamma di settori economici per facilitare l’acquisto e la vendita di beni e servizi tra Europa e Stati Uniti; oltre a ridurre le tariffe in tutti i settori, l’Unione europea e gli Stati Uniti vogliono affrontare il problema delle barriere doganali – come le differenze nei regolamenti tecnici, le norme e le procedure di omologazione».
Gli studi mostrano che gli effetti economici del libero commercio avvantaggino le imprese più internazionalizzate e competitive, favorendo l’espulsione dal mercato delle imprese meno efficienti; le imprese possono delocalizzare e multi-localizzare le proprie attività e sedi nei diversi contesti che offrono maggiori vantaggi produttivi, logistici, fiscali, di presidio del mercato e di valore aggiunto. Gli effetti sull’occupazione dell’internazionalizzazione dei mercati sono noti. Se l’Unione europea riuscisse a portare a termine tutti gli attuali negoziati, il suo Pil crescerebbe del 2,2%, oltre 275 miliardi di euro.
Secondo le stime Ue, la zona di libero scambio farebbe risparmiare alle imprese europee diverse decine di miliardi di euro all’anno.
La rimozione totale su tutte le merci delle tariffe doganali, che attualmente sono del 5,2% nella Ue e del 3,5% negli Usa, secondo le stime del WTO, comporterà anche l’abolizione delle barriere non tariffarie.
I diversi standard tra Usa e Ue sono, infatti, considerate l’ostacolo principale al commercio fra le due sponde dell’Atlantico.
Lo sviluppo di standard e procedure comuni sarà ritenuto il principale risultato positivo; da parte europea, tuttavia, si punta a evitare ogni revisione delle norme sugli OGM, su cui la Ue ha norme fortemente restrittive.
Nel settore dell’agroalimentare la Ue, ad esempio, ha regole più restrittive sull’uso di ormoni nei bovini e sul trattamento del pollame.
Gli Usa, dal canto loro, potrebbero aprire all’importazione di suini vivi, in cambio di quote di export di altre carni. Inoltre, si pone la questione del riconoscimento delle indicazioni geografiche d’origine.
Tale tema è molto sentito da parte italiana: sulle indicazioni geografiche, la partita che sta giocando l’Italia è sul riconoscimento, da parte del Trattato, della normativa europea di tutela dei prodotti tipici locali (Igp, Doc, Dop), come ha fatto recentemente il Canada.
A fianco dell’Italia, si trovano schierate anche Spagna, Grecia e Francia, altrettanto determinate a veder riconosciute le proprie “specialità”, costringendo la Commissione Ue ad accogliere le loro istanze sul mandato negoziale.
Negli Stati Uniti, questa tematica si sta trasformando in un caso politico.
L’industria alimentare Made in Usa è un autentico gigante economico; basti pensare che il solo settore lattiero-caseario è formato da 51.000 aziende, di cui il 97% a gestione familiare, con 900.000 addetti e con una movimentazione di oltre 140 miliardi di dollari dal produttore al consumatore.
Lo stesso, però, vale anche per l’Italia: a fronte di un export alimentare negli Usa, che nel 2013 è stato di 2,8 miliardi di euro, c’è un’industria americana di prodotti ispirati al Made in Italy (dal parmesan all’asiago, dal prosciutto alla mozzarella) che fattura ben 24 miliardi di euro (Fonte: Il Sole 24 Ore).
Fonte: www.eurispes.eu