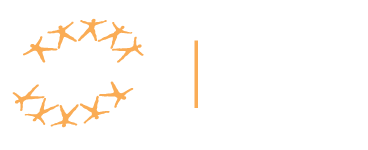Indice dell’Esclusione: la misura delle diseguaglianze nei territori

Eurispes: Indice di esclusione
La misura delle diseguaglianze nei territori
Presentato questa mattina a Roma presso la Sala dell’Istituto di Santa Maria in Aquiro del Senato della Repubblica lo studio dell’Eurispes incentrato sulla costruzione e sull’analisi di un Indice dell’Esclusione, concepito come strumento multidimensionale per misurare, a livello regionale, quanto e come i diritti costituzionali siano disattesi nella quotidianità dei cittadini. L’approccio adottato non si limita a fotografare le disuguaglianze economiche, ma intende mappare le molteplici forme di marginalizzazione che ancora oggi limitano la piena cittadinanza di milioni di persone, configurandosi come esiti strutturali di processi storici di esclusione piuttosto che come semplici ritardi congiunturali di sviluppo.
Per la costruzione dell’indice, nel complesso sono stati selezionati 149 indicatori distribuiti nei 7 ambiti tematici (Lavoro – Economia – Diritti sociali – Accesso ai servizi – Salute – Istruzione e conoscenza – Diritti trasversali), secondo criteri di significatività nella descrizione del fenomeno e disponibilità di dati regionali comparabili. Per facilitare la lettura dei risultati, le regioni, sia per gli indici settoriali sia per quello generale, sono state suddivise in fasce di esclusione “alta”, “medio alta”, “medio bassa” e “bassa”. A seguire i risultati di ogni singolo ambito e, successivamente, quelli dell’Indicatore generale.
L’esclusione dal diritto al lavoro
L’esclusione dal diritto al lavoro è misurata attraverso 21 indicatori che includono indicatori classici come tassi di occupazione e di disoccupazione, indicatori di esclusione più mirati come la disparità di genere occupazionale e nel part time involontario o il tasso di imprenditorialità giovanile e indicatori soggettivi come la soddisfazione per il lavoro svolto e la percezione di insicurezza dell’occupazione.
In questo ambito le posizioni più critiche sono tutte occupate da regioni meridionali, con Sicilia, Calabria e Campania in testa, mentre le regioni che riescono a garantire condizioni lavorative migliori si concentrano fra il Nord-Ovest (Lombardia in vetta) e il Nord-Est.
Guardando ai singoli indicatori il Mezzogiorno emerge come sistematicamente penalizzato in quasi tutte le dimensioni: in molte regioni del Sud, la combinazione di fragilità strutturali, la bassa mobilità e la carenza di opportunità lavorative qualificate rafforza una condizione di esclusione dal mondo del lavoro che è non solo quantitativa ma anche qualitativa e colpisce in particolare i giovani e le donne.
Al contrario, il Nord – e in misura leggermente minore il Centro – mostrano valori più virtuosi e maggior equilibrio fra le variabili pur non mancando anche in queste aree segnali di criticità, come la persistenza di disparità di genere e la presenza non trascurabile di forme di lavoro precario.
Un indicatore su tutti registra la massima disuguaglianza: la mobilità dei laureati. Il saldo migratorio dei laureati raggiunge il -44,7% in Basilicata (quasi la metà dei laureati si trasferisce) ed è superiore al -30% in quasi tutte le regioni del Sud, mentre ad esempio l’Emilia-Romagna con un saldo del +23% si distingue per la capacità di attrarre forza lavoro qualificata. Occorre sottolineare che il valore medio italiano del -4,5% segnala un’incapacità generale del Paese di trattenere giovani e lavoratori altamente qualificati. Nel complesso l’analisi degli indicatori lavoro evidenzia la coesistenza sul territorio nazionale di mercati del lavoro molto distanti, che generano agli opposti circoli virtuosi di inclusione o di marginalizzazione lavorativa.
L’esclusione economica
L’ambito di esclusione economica è calcolato attraverso 16 indicatori che misurano non solo il reddito disponibile, ma la capacità di famiglie e individui di condurre un’esistenza dignitosa, di progettare il futuro e di far fronte agli imprevisti. Ancora una volta le posizioni peggiori della classifica sono occupate dal Mezzogiorno e le migliori da regioni del Nord-Est e del Nord-Ovest. Al Nord-Ovest si distingue negativamente la Liguria e al Centro il Lazio, entrambe con un livello di esclusione economica medio-alto. La Liguria, ad esempio, evidenzia una forte incidenza della spesa sul reddito, combinata a difficoltà diffuse nel pagamento di mutui e affitti come anche il Lazio che, nonostante un reddito medio disponibile superiore alla media, mostra sacche di rischio di povertà molto elevate. In generale il Mezzogiorno mostra livelli più elevati di vulnerabilità su quasi tutte le dimensioni esaminate.
Anche in questo caso alcuni numeri possono essere esemplificativi dell’ampiezza delle disparità: la grave deprivazione materiale e sociale colpisce circa il 20% dei residenti in Calabria, mentre non raggiunge l’1% in Emilia-Romagna, ed è a rischio povertà il 40,6% della popolazione calabrese, il 38% di quella siciliana il 36% di quella campana, i valori registrati in Trentino-Alto Adige ed Emilia Romagna sono circa sei volte inferiori.
Esclusione dai diritti sociali
L’ambito di esclusione dai diritti sociali è costruito su 19 indicatori che misurano la dotazione di capitale sociale e culturale dei territori e la loro capacità di offrire opportunità di aggregazione, partecipazione e crescita individuale e collettiva. Il panorama più critico si osserva anche in questo caso nelle regioni meridionali, che occupano interamente la fascia di esclusione “alta” e “medio-alta”. In queste aree, la scarsa disponibilità di risorse pubbliche per la protezione sociale e per le attività culturali si somma a una minore dotazione di spazi aggregativi. La condizione di marginalità è ulteriormente accentuata dall’insufficiente rappresentanza femminile nelle Istituzioni locali e dalla minore diffusione di pratiche di volontariato organizzato. All’estremo opposto troviamo le regioni virtuose del Nord-Est a cui si aggiunge la Lombardia.
L’incidenza della popolazione che vive in Comuni privi di offerta di spettacolo, intrattenimento e sport registra la massima disuguaglianza nazionale, con contesti del tutto sprovvisti di opportunità culturali, in particolare in Calabria, a differenza di regioni come Emilia Romagna e Toscana che riescono a garantire l’offerta su tutto il territorio regionale.
Anche la partecipazione culturale mostra divari enormi: i cittadini che si sono astenuti da qualsiasi forma di intrattenimento (come la lettura di libri, quotidiani o partecipazione a spettacoli e altre forme di intrattenimento culturale fuori casa) superano il 43% in Basilicata e Calabria, in Trentino-Alto Adige si arriva solo al 14,8%.
Sul fronte della pratica sportiva Calabria Campania e Sicilia sono agli ultimi posti per partecipazione, al contrario di Valle d’Aosta e Trentino Alto Adige che, nonostante una bassa densità di società sportive, registrano i tassi di partecipazione più alti.
Nel complesso in questo ambito emergono tre linee di frattura: quella già evidenziata anche negli altri Indicatori di carattere geografico che contrappone il Centro-Nord al Sud, una che separa i centri urbani dalle aree periferiche e la terza fra aree densamente abitate e a bassa densità demografica.
L’esclusione dai servizi
L’ambito dei servizi, il più ricco con 28 indicatori, misura la capacità del sistema pubblico di garantire prestazioni essenziali a cittadini e famiglie. Anche l’Indice di esclusione dai servizi penalizza soprattutto il Mezzogiorno, ma evidenzia criticità anche in alcuni contesti del Centro e del Nord. In particolare, a regioni meridionali quali Campania, Calabria, Sicilia e Puglia si aggiunge nella fascia alta di esclusione il Lazio e, in quella medio-alta troviamo la Liguria. Le differenze territoriali emergono con chiarezza in alcuni indicatori chiave: irregolarità nella distribuzione dell’acqua e del servizio elettrico, diffuse difficoltà nel raggiungere servizi essenziali quali pronto soccorso, servizi postali, Forze dell’ordine e sedi degli uffici comunali alte non solo al Sud, ma anche nel Lazio, Liguria e talvolta Toscana e Umbria; anche il servizio di TPL, per offerta, utenza e livelli di soddisfazione risulta tendenzialmente migliore in aree del Centro‑Nord. Il digitale pubblico contribuisce ad aumentare la distanza: la quota di Comuni con servizi per le famiglie interamente online e i livelli di interazione web con la PA risultano più avanzati nelle regioni del Nord. Sul fronte dei servizi per la prima infanzia, le regioni settentrionali ottengono mediamente risultati migliori sia per posti pubblici disponibili sia per tassi di presa in carico. Si tratta di indicatori particolarmente rilevanti perché incidono sia sulle opportunità delle madri di inserirsi efficacemente nel mondo del lavoro, sia dei bambini di accedere precocemente al sistema educativo.
In questo àmbito, l’esclusione non si manifesta tanto nella forma della negazione esplicita di un diritto, quanto nella sua erosione silenziosa con servizi che esistono formalmente ma sono troppo distanti, poco affidabili, mal distribuiti, carenti di personale o tecnologicamente inadeguati.
Il diritto alla salute
L’ambito Salute si fonda su 23 indicatori che valutano dotazioni, esiti e accessibilità del Servizio sanitario, nonché i livelli di soddisfazione e fiducia degli utenti. Le posizioni più critiche sono ancora una volta tutte nel Mezzogiorno e includono Calabria, Campania, Sardegna, Puglia e Sicilia mentre Veneto, Liguria, Emilia Romagna, Toscana e Trentino Alto Adige compongono il gruppo più inclusivo.
In questo ambito alcuni numeri sono esplicativi di una distanza profonda in un settore fondamentale per la vita dei cittadini. Solo per citarne qualcuno, la speranza di vita in buona salute alla nascita varia dai 66,2 anni del Trentino ai 53,1 della Calabria: tredici anni di differenza che creano una disparità enorme sulla qualità di vita attesa da un neonato trentino e uno calabrese. Il tasso di mortalità evitabile oscilla tra il 15% del Trentino e il 25% della Campania. L’emigrazione ospedalieraraggiunge il 32,6% in Molise, con quasi 1 cittadino su 3 che cerca cure in un’altra regione, una distanza abissale con la Lombardia ferma al 5,1%.
La conseguenza sono livelli di soddisfazione per le prestazioni ricevute nettamente più alte al Nord che al Sud e livelli di fiducia nel sistema sanitario mediamente inferiori nel Mezzogiorno, sebbene il Sud si distingua spesso positivamente per la copertura medica di base (sia pediatrica che per i MMG). Un’analisi che nel suo complesso conferma che il diritto alla salute, pur formalmente garantito a tutti i cittadini, presenta nella sua attuazione concreta forti disparità territoriali.
L’esclusione educativa
L’ambito Istruzione e conoscenza aggrega 23 indicatori che attraversano l’intero ciclo educativo, fino ad arrivare alla capacità del sistema di sostenere la formazione permanente e l’aggiornamento degli adulti. L’Indice vede le Marche primeggiare per capacità inclusiva e la Sicilia nella posizione più critica.
Anche in questo caso citiamo solo alcune delle disparità emerse. L’abbandono scolastico varia dal 5,6% dell’Umbria al 17,3% della Sardegna. I NEET oscillano dall’8,8% del Trentino-Alto Adige fino a superare il 27% in Sicilia e Calabria, il che significa che in queste regioni quasi un giovane su tre non studia e non lavora, risultando così escluso da due circuiti fondamentali per lo sviluppo della persona. Anche sul fronte delle competenze si registrano ampissimi divari: in Sicilia e Calabria più della metà degli studenti mostra competenze alfabetiche inadeguate, mentre in Umbria, regione più virtuosam ci si ferma al 32% e il divario è ancora più ampio per le competenze numeriche che vedono le stesse due regioni come fanalino di coda.
Non mancano eccellenze in alcuni indicatori fra le regioni meridionali e criticità specifiche al Nord: ad esempio la differenza di genere fra i laureati STEM è minima in Sardegna e Calabria e massima in Trentino-Alto Adige; la Valle d’Aosta ha la percentuale più bassa di scuole con postazioni informatiche adibite all’integrazione degli alunni con disabilità e gli studenti del Trentino Alto Adige ad un anno dal diploma sono quelli che meno spesso hanno intrapreso un percorso di studi universitario, ma nel complesso il Mezzogiorno resta in posizione di svantaggio rispetto al Centro-Nord.
I diritti trasversali
L’ambito dei Diritti trasversali composto da 21 indicatori integra dimensioni ambientali, di sicurezza e di funzionamento istituzionale.
Questo ambito dell’Indice mostra una geografia inedita dell’esclusione con il Lazio che occupa il vertice negativo, seguito da Campania, Puglia, Lombardia, e Umbria segnalando come l’esclusione trasversale non coincida necessariamente con la marginalità economica ma possa manifestarsi anche in territori più solidi dove si intrecciano problemi ambientali, di sicurezza e governance.
Questo ambito presenta le maggiori disuguaglianze territoriali: la disponibilità di verde urbano varia dai circa 319 mq per abitante in Trentino Alto Adige e Molise per crollare a 10,6 mq per abitante in puglia; in molte regioni del Sud più della metà dell’acqua immessa nella rete viene dispersa prima di raggiungere l’utenza finale, con il valore peggiore in Basilicata dove si supera il 65%, mentre in quasi tutte le regioni del Nord i valori sono inferiori al 35%; un’altra differenza sostanziale si registra sui tempi della giustizia: un procedimento civile si conclude in media entro sei mesi in Valle d’Aosta ed a arriva a superare i due anni in Basilicata.
Nei contesti urbani metropolitani emergono criticità come livelli più alti di delittuosità e di percezione di degrado con Lazio in testa seguito per entrambi gli indicatori dalla Lombardia; al contrario, valori molto più contenuti caratterizzano diversi territori alpini e alcune regioni del Sud. Nel complesso, la mappa dei diritti trasversali mostra che la realizzazione di un modello di sviluppo che tenga insieme crescita economica, sostenibilità ambientale, sicurezza sociale ed efficienza istituzionale è una delle sfide più complesse nella garanzia della piena cittadinanza.
I risultati dell’Indice generale
Questa lettura preliminare dei risultati dei singoli ambiti è necessaria per comprendere i risultati dell’Indice generale, che non rappresenta una semplice media delle performance settoriali, ma cattura la natura sistemica e interconnessa dell’esclusione attraverso la penalizzazione degli squilibri interni.
Il Sud e le Isole si confermano le aree in cui la distanza dal godimento dei diritti fondamentali è più intensa. Nella fascia “alta” di esclusione troviamo Calabria, Campania, Sicilia, Puglia e Basilicata, in quella “medio-alta” Molise, Sardegna, Abruzzo, Lazio e Liguria, nella “medio-bassa” Piemonte, Umbria, Marche, Veneto e Toscana, mentre le regioni in fascia bassa sono Lombardia, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Valle d’Aosta e Trentino-Alto Adige. In sintesi abbiamo nella fascia Alta: 5 regioni del Mezzogiorno; Medio-alta: 3 regioni del Mezzogiorno, una del Centro (Lazio) e una del Nord-Ovest (Liguria); Medio-bassa: 3 regioni del Centro, una del Nord-Ovest e una del Nord-Est; Bassa: 3 del Nord-Est e due del Nord-Ovest. Questa geografia dell’esclusione disegna una mappa di un Paese in cui la possibilità per i cittadini di esercitare i propri diritti segue una linea territoriale chiara che separa Sud, Centro e Nord; e il Mezzogiorno emerge chiaramente come epicentro di un’esclusione che assume caratteri sistemici e auto-replicanti.
Oltre ai risultati generali è utile soffermarsi su alcuni squilibri specifici emersi.
L’eccellenza Nord-orientale: un modello non privo di squilibri
Il Nord-Est, sebbene si configuri come modello avanzato di inclusione e coesione, mostra alcune debolezze non trascurabili. Il Trentino-Alto Adige è l’emblema di queste contraddizioni: infatti nonostante una situazione complessivamente eccellente, mostra forti segnali di esclusione nei confronti delle donne. La regione presenta l’imprenditoria femminile al minimo nazionale, il più alto gender gap salariale d’Italia, un’occupazione delle donne con figli sotto la media nazionale e il più profondo differenziale di genere nelle lauree STEM.
L’esclusione digitale: nuova frontiera della marginalizzazione
Un altro aspetto che merita particolare attenzione è quello del divario digitale. L’esclusione digitale è infatti oggi una delle più gravi forme di disuguaglianza che ha impatti concreti in tutti i domini della vita e sulla reale possibilità di godere pienamente della cittadinanza.
Per le competenze digitali di base la media nazionale già di per sé bassa, ferma al 45,9%, contro una media europea del 55,6%, crolla al 32% in Calabria; Campania Sicilia Basilicata e Puglia sono tutte sotto il 40% e le restanti regioni del Mezzogiorno tutte comunque al di sotto della media nazionale.
A livello nazionale, il 77,7% della popolazione utilizza regolarmente Internet, un dato nettamente più elevato rispetto alla percentuale di chi possiede competenze digitali di base che indica che molti italiani utilizzano abitualmente la Rete pur non disponendo delle competenze minime per farlo in modo sicuro e consapevole. Le percentuali di utilizzo regolare variano dal minimo del 67,6% in Calabria a valori superiori all’81% in Emilia-Romagna, Lombardia e Lazio. In generale nelle Regioni in cui l’alfabetizzazione digitale è più diffusa, si osserva anche un utilizzo più costante della Rete sebbene anche in questi territori lo scarto tra utilizzo e competenze rimanga molto elevato.
Sul piano della dotazione tecnologica in Lombardia il 74% delle famiglie dispone di computer e connessione internet mentre la Calabria precipita al 54% e, sono particolarmente gravi anche i ritardi nella digitalizzazione dei servizi pubblici locali: mentre in Veneto il 78,6% dei Comuni offre servizi per le famiglie interamente online, in Molise lo fa appena il 24%, con un divario di oltre 50 punti percentuali. Si tratta solo di alcuni degli indicatori che mettono in luce l’esistenza di una specifica forma di esclusione, quella digitale, che necessita di interventi urgenti di riequilibrio per evitare che il digital divide diventi una nuova questione meridionale.
Il divario di genere: l’altra faccia dell’esclusione
Infine, il divario di genere attraversa trasversalmente tutti i territori, incidendo in particolare sul mercato del lavoro. Il rapporto tra tassi di occupazione delle donne con figli in età prescolare e quelle senza figli mostra differenziali altissimi; l’imprenditoria femminile resta ovunque sotto i livelli di parità, il part-time involontario colpisce prevalentemente le donne e il gender gap salariale persiste anche nelle regioni più ricche. L’Indice evidenzia l’esistenza di modelli territoriali diversificati di discriminazione di genere: il modello meridionale si caratterizza per un’Esclusione multidimensionale che investe simultaneamente accesso al lavoro, livelli retributivi, conciliazione vita-lavoro e rappresentanza politica. Il modello settentrionale presenta invece forme più sofisticate e nascoste di discriminazione: pur garantendo maggiore accesso al mercato del lavoro, perpetua disparità retributive e mantiene barriere invisibili alla progressione di carriera femminile. La presenza di mercati del lavoro più dinamici non elimina dunque il cosiddetto “soffitto di cristallo” che limita l’accesso delle donne ai ruoli apicali e meglio retribuiti.
L’Italia e l’Europa
In conclusione dell’analisi, il confronto con l’Europa rivela che l’esclusione territoriale interna all’Italia si intreccia con un ritardo strutturale rispetto ai principali standard europei in molti àmbiti. Le disuguaglianze Nord-Sud si inseriscono all’interno di un quadro complessivo che vede l’Italia distante dalla media Europea nei principali indicatori di inclusione sociale ed economica (tasso di occupazione, gender gap occupazionale, fenomeno dei Neet, competenze digitali, rischio di povertà), per i quali spesso anche le eccellenze del Nord non raggiungono i valori medi europei a conferma di una diffusa fragilità nazionale.
Questa doppia dimensione dell’esclusione – quella interna tra territori italiani e quella dell’Italia rispetto all’Europa – configura una sfida ulteriore per le politiche pubbliche perché non si tratta solo di ridurre i divari tra Nord e Sud, ma di elevare l’intero sistema-Paese evitando che la convergenza territoriale avvenga verso standard inadeguati anziché verso parametri di eccellenza.
LA RICERCA IN VERSIONE INTEGRALE È SCARICABILE CLICCANDO QUI
Eurispes – Istituto di Studi Politici Economici e Sociali
ufficiostampa@eurispes.eu – www.eurispes.eu